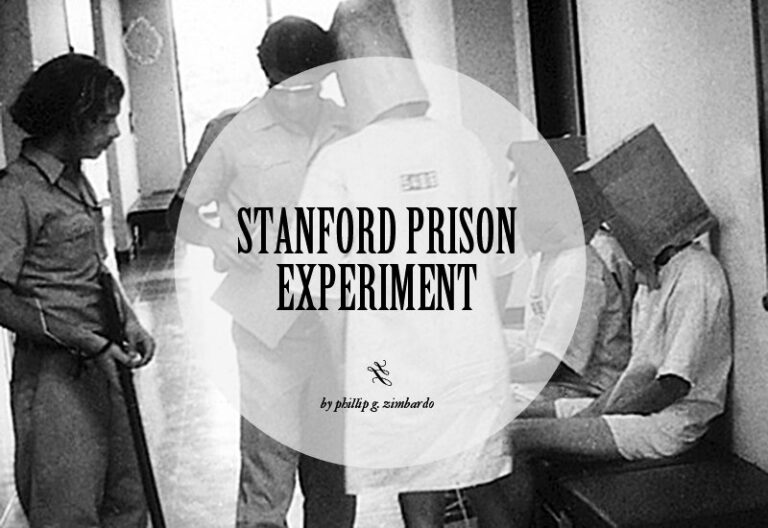Psicologia sociale: I gruppi sociali
I punti fondanti della psicologia sociale sono il gruppo e l’influenza sociale e la loro interconnessione con gli individui.
È dunque necessario definire cosa sia un gruppo, quali sono le teorie dell’influenza sociale e i processi di soggettivazione innescati dall’appartenenza ad un gruppo che producono identità.

I gruppi sociali essendo l’oggetto di studio cardine della psicologia sociale sono stati più volte soggetti a differenziazioni caratterizzate in base alla loro origine, composizione o funzione.
La prima distinzione è stata fatta da Cooley (Cooley, 1909) che ha distinto i gruppi in primari e secondari.
I gruppi primari sono quelli caratterizzati da una interazione diretta tra i membri di tipo “faccia a faccia” e sono fondati principalmente sull’affiatamento e l’identificazione reciproca; ne sono un esempio la famiglia, i compagni di gioco, il gruppo degli amici.
I gruppi secondari sono quelli più formali in cui non sempre è possibile una interazione uno a uno tra i membri e hanno una estensione maggiore.
A questa definizione originaria di Cooley possono essere sovrapposte altre caratterizzazione di gruppi che, ad esempio, sono stati descritti come formali e informali. Questi ultimi sono la famiglia e gli amici in quanto non sono artificialmente costruiti ma si formano in maniera naturale, mentre quelli formali sono costruiti da convenzioni o contrattualizzazioni o regole.
Secondo una definizione che si riferisce ai principi della Gestalt possiamo parlare di gruppo quando gli individui che ne fanno parte hanno per lo meno la potenzialità di avere tra di loro delle interazioni e quando vi è una interdipendenza nel compito e nel “destino”. Vale a dire che i soggetti che identifichiamo come appartenenti a tale gruppo sentono di avere un “destino comune” che li lega e non per le caratteristiche di somiglianza o diversità ma le interazioni che si producono tra loro, che queste interazioni abbiano una certa frequenza e che vi sia una interdipendenza tra i soggetti (Attili, 2011).
Questa definizione comporta qualche problema di ordine pratico nel momento in cui si pensa a gruppi con un’ampia estensione quelli così detti “macro-sociali” che si distinguono da quelli “micro-sociali” proprio in base a tale variabile numerica. È necessario dunque trovare definizioni più ampie che permettano una descrizione più generale degli aggregati come gruppo.
Asch (1952) definisce il gruppo tramite un’analogia con la chimica; la molecola dell’acqua è l’unione di idrogeno e ossigeno che non si sommano ma si combinano per formare l’H2O. Il gruppo è dotato dunque, di proprietà uniche che emergono dalla rete di relazione tra i singoli membri (Sherif 1936, Asch 1952, Lewin 1952) e dalla percezione che questi hanno di sé stessi in qualità di membri della medesima unità sociale e nelle varie relazioni reciproche all’interno di tale unità. L’essere membro di un gruppo e i comportamenti tenuti in quanto soggetto appartenente ad un gruppo specifico ha conseguenze psicologiche specifiche anche se il gruppo non è immediatamente presente (Brown, 2000).
Un gruppo ha comportamenti specifici in relazione ad altri gruppi (dinamiche intergruppi) e all’interno del gruppo stesso (dinamiche infragruppo).

Lewin (1972) dice che il gruppo è una totalità dinamica vale a dire che è “qualcosa di più e di diverso dalla somma delle singole parti”; nella sua definizione si riuniscono aspetti già citati prima quali l’interdipendenza , distinta in due tipi: interdipendenza del destino e interdipendenza del compito.
La prima, è un elemento macroscopico di unificazione e consiste nella sensazione di essere nella stessa situazione e nella percezione di far parte dello stesso gruppo. È quella che generalmente viene definita come senso di appartenenza ad un gruppo. Il secondo tipo di interdipendenza invece è «un elemento più forte e più diretto dell’interdipendenza del destino, poiché fa sì che lo scopo del gruppo determini un legame fra i membri in modo tale che i risultati delle azioni di ciascuno abbiano delle implicazioni sui risultati degli altri» (Speltini, Palmonari, 1999). Una persona si comporta diversamente se si percepisce come appartenente ad un gruppo o meno, se si trova in presenza di un gruppo considerato come opposto (outgroup) o se si trova ad interagire con persone che percepisce come appartenenti allo stesso gruppo sociale (ingroup).
Lewin afferma dunque che il comportamento (“C”) di un soggetto scaturisce dall’interazione tra le variabili personali (“P”) e quelle ambientali (“A”), trovando il punto d’incontro tra soggetto e gruppo e formula a tale proposito l’equazione “C= f (P, A)” (Lewin, 1972).
Il paradigma dei gruppi minimi di Tajfel afferma che un insieme di persone per essere considerate un gruppo devono essere categorizzati come appartenenti allo stesso gruppo ed essere definiti come tali in opposizione ad un altro gruppo. Quando si divide un insieme di persone in due gruppi, in maniera arbitraria, il principio di azione che guida entrambi è quello di massimizzare le differenze, quindi in tale ottica il pregiudizio si colloca all’interno di un processo cognitivo ‘normale’ (Brown, 1995).
Nel momento in cui ci si trova in una situazione di suddivisione in ingroup e outgroup (anche arbitraria, così come detto nel paradigma dei gruppi minimi) il processo di categorizzazione agisce su due livelli: amplificando le differenze fra gruppi e rafforzando le somiglianze all’interno del gruppo; di conseguenza il pensiero più frequentemente esplicitato è : “loro sono tutti uguali, noi siamo tutti diversi” (anche se non sono fenomeni simmetrici). Tale fenomeno è denominato omogeneizzazione dell’outgroup e può avvenire per motivi diversi; a riguardo ci sono due ipotesi: La prima si riferisce al grado di familiarità con l’outgroup (e quindi il livello di informazioni disponibili sui suoi membri). Tale ipotesi presenta due problemi prima di essere accolta come valida: non ci sono sufficienti prove empiriche che la sostengono e, in secondo luogo, l’effetto di omogeneizzazione del gruppo esterno avviene, nella situazione di un gruppo minoritario, all’interno dell’ingroup. La seconda ipotesi di spiegazione del fenomeno di omogeneizzazione si riferisce al riconoscimento da parte di chi osserva di membri prototipici all’interno dell’outgroup (Brown, 1995), cosa che ha un collegamento diretto con il riconoscimento di se stessi come appartenenti ad un gruppo e che comporta due microprocessi: l’adattamento dell’individuo al prototipo dell’ingroup e l’ amplificazione massima possibile della distanza con il prototipo dell’outgroup. Questo comporta una capacità di riconoscimento maggiore, all’interno dell’ingroup, delle caratteristiche di similarità dai membri (Turner et al., 1987). Un esempio può essere le caratteristiche che si attribuiscono ai cinesi in Italia: sono tutti uguali. La percezione delle loro caratteristiche fisiche è l’emblema dell’effetto di omogeneizzazione dell’outgroup.
L’ identità
L’identità è definita da « […] il senso del proprio essere continuo attraverso il tempo e distinto, come entità, da tutte le altre» (Galimberti, 2006).

Da questa definizione si evincono due concetti fondanti l’identità: la continuità temporale e l’essere unici di ogni individuo rispetto agli altri; come dire che l’identità è data dall’avere una storia e dal percepire le somiglianze e differenze con gli altri individui.
Tale definizione è calzante sia se si descrive l’identità personale sia se ci si riferisce all’identità sociale. Secondo la Social Identity Theory di Tajfel tali due identità sono posti lungo un continuum che va dal confronto intragruppi al confronto intergruppi e si basa sull’assunto che ognuno di noi, in quanto esseri sociali apparteniamo a gruppi sociali e classifichiamo noi stessi in base a tale appartenenza. La teoria di Tajfel, infatti, si basa sulla Self Categorization Theory di Turner (1999), secondo la quale gli essere umani tendono naturalmente a categorizzare sé stessi e gli altri in base all’appartenenza ad uno o più gruppi sociali ben specifici seguendo il principio del meta-contrasto. La self categorization theory (ibidem, 1999) sostiene che il concetto di Sé si costruisce tramite dei processi di categorizzazione personale all’interno di un determinato gruppo sociale. La categorizzazione di qualunque stimolo, compreso il Sé all’interno di un gruppo sociale, dipende dalla salienza dello stimolo per il soggetto stesso (Adams, Hogg, 2000). L’auto-identificazione che ne deriva è determinata dalle categorie sociali che si presentano al soggetto come alternative. Alla base della teoria della categorizzazione del Sé ci sono degli assunti fondamentali ampiamente condivise dalla psicologia sociale.
Il primo di tali assunti è che il concetto di sé si può definire come l’insieme delle rappresentazioni cognitive di sé di cui una persona dispone ed è per questo che ogni individuo possiede concetti di sé multipli: tanti quante sono le rappresentazioni possedute. Il sé è, inoltre, una struttura cognitiva utilizzata nella elaborazione delle informazioni; tale concetto è situazione-specifico, vale a dire che è ‘attivato’ producendo specifiche immagini di sé che diventano salienti in base alla situazione. Il concetto di sé sociale consiste nel riconoscere la compresenza di identità nello stesso soggetto ad almeno tre livelli di astrazione: il livello sovraordinato del sé di ‘identità umana’ che è quella più astratta e generale e riferita alla specie di appartenenza in contrasto con altre forme di vita (che quindi si basa sui confronti interspecie); il livello intermedo detto di ‘identità sociale’ relativa ai gruppi sociali ai quali si appartiene che si articola in una dialettica di ingroup-outgroup (confronto intergruppo). Un esempio può essere l’identificarsi come italiano piuttosto che francese, inglese o norvegese in quanto ci si definisce in base alla nazione di appartenenza, confrontandosi con gli altri gruppi nazionali per quanto riguarda la lingua o il territorio in cui si abita. In fine, vi è il livello subordinato dell’ ‘identità personale’ basato sulla differenziazione di sé stessi come individui unici dagli altri membri del gruppo. All’interno dei livelli di astrazione su individuati ci possono essere delle distinzioni di categorie più sottili; per esempio, nel livello sociale, ci sono ingroup e outgroup nazionali e sovranazionali come la Nato, l’Europa e l’Occidente (Turner, 1999). L’uomo appartiene contemporaneamente a molteplici gruppi sociali e, quindi, ha identità sociali diverse in base al contesto in cui si trova. In realtà le varie identità sociali coesistono tra loro e insieme all’identità personale del soggetto e non confliggono, generalmente, tra di loro. Questo accade anche perché le categorie sociali in cui ci si classifica, si trovano a livelli diversi di astrazione che, come se fossero cerchi concentrici , si contengono l’uno nell’altro. In base al contesto si ha una salienza maggiore di una identità sociale rispetto ad altre che però non scompaiono, semplicemente passano in secondo piano nella percezione del soggetto e nell’autodefinizione della propria identità. Tale meccanismo ubbidisce al principio del meta- contrasto, di cui un esempio può essere l’identificarsi come spagnolo piuttosto che francese perché si risiede in Spagna e non in Francia, si parla lo spagnolo e non il francese, oppure il definirsi come persone aperte e non introverse perché ci si riconoscono estroversione, cordialità e accoglienza e non riservatezza e chiusura verso la conoscenza degli altri. La salienza di una categoria dipende dal sistema di riferimento in quella data situazione. La salienza porta ad accentuare le somiglianze intraclasse e le differenze interclassi, per tanto, vi è quindi un antagonismo funzionale tra la salienza di un livello di categorizzazione e gli altri. Questo funzionamento si percepisce bene nel momento in cui ci si trova in un contesto in cui c’è un’unica caratteristica predominante: ad esempio in un comizio politico di un partito aumenta la salienza della mia identità politica ovvero dalla mia appartenenza ad un partito di destra, sinistra o centro. Quando ad esempio ci si trova in un contesto multiculturale, la salienza della propria identità nazionale aumenta e si tende a rilevare le caratteristiche che differenziano dagli altri gruppi nazionali in una sorta di attenzione selettiva per le differenze a favore di un’accentuazione delle peculiarità nazionali. I fattori che aumentano la salienza delle categorizzazioni lungo l’asse ingroup-outgroup tendono a far aumentare l’identità percepita tra sé e i membri dell’ingroup (e la differenza rispetto ai membri dell’outgroup) e quindi provocano un fenomeno depersonalizzazione. Quest’ultimo è un processo di ‘stereotipizzazione del Sé’- alla base di molti fenomeni di gruppo come, ad esempio, la coesione di gruppo, l’altruismo e l’etnocentrismo- attraverso cui le persone tendono a percepirsi come membri intercambiabili di una categoria sociale (Turner, 1999).
Appartenere ad un determinato gruppo sociale, identificarsi come membro dello stesso e quindi percepire chiaramente una identità sociale legata a tale gruppo ha dei consistenti benefici psicologici. Questo è vero se il gruppo di appartenenza ha caratteristiche che noi reputiamo positive, cosa che permette un mantenimento dell’autostima personale. Ma a tale spinta alla uniformità con le caratteristiche del gruppo sociale di appartenenza che si rende saliente in un determinato contesto, spesso si contrappone una spinta di uguale forza alla differenziazione dallo stesso.
Brewer, nella sua teoria della distintività ottimale afferma che ogni soggetto, con lo scopo di mantenere una immagine di sé adeguata e sufficientemente positiva risponde contemporaneamente all’esigenza di assimilarsi all’esemplare del gruppo sociale di appartenenza (per rassicurare sé stesso nella sua identità tramite il confronto e la similitudine con qualcosa di familiare) e di differenziarsene (tramite il rilevamento delle differenze con l’esemplare del gruppo stesso). Un esempio può essere l’identificarsi come di cristiano ma contemporaneamente riconoscere la non effettiva aderenza a tutti i dogmi della cristianità, cosa che si rileva spesso in contesti multiculturali. Ad esempio, si riconoscono determinate caratteristiche degli italiani come la simpatia, il calore e l’eleganza ma contemporaneamente ci si distanzia dallo stereotipo dell’italiano medio sfaticato, sempre in ritardo e interessato solo alla bella vita, riconoscendone le differenze con la propria identità personale che, può non includere alcune caratteristiche dell’”italianità” come quelle appena descritte.
Questa contemporanea accettazione e distanziamento dallo stereotipo dimostra come, anzitutto, tale immagine sia conosciuta dai cittadini di una determinata nazione. In secondo luogo è il meccanismo caratterizzante la cultural intimacy così come è descritta dall’antropologo Herzelfeld (2003). L’intimità culturale è il riconoscimento e la denigrazione dello stereotipo che dimostra l’effettiva appartenenza del soggetto alla propria nazione. Tale stereotipo, contenendo anche gli aspetti nazionali negativi, spesso, suscita imbarazzo nei cittadini che tendono a screditare la propria nazionalità all’interno della propria nazione, nominandosi spesso come diversi dalla rappresentazione stereotipica, che viene subito richiamata alla mente. La conoscenza dello stereotipo e quanto appena detto a riguardo, dimostra la colorazione affettiva verso il proprio Stato e la forza dell’identità che ne deriva.
La possibilità di individuare un ‘esemplare’ permette agli appartenenti al gruppo di definirsi in base alla somiglianza e alla differenziazione dallo stesso, così come vuole il principio del meta contrasto della teoria di Turner. Il costituirsi dell’ identità nazionale è legato imprescindibilmente al senso di appartenenza ad un gruppo descritto come senso di comunità, ovvero come «la certezza soggettiva che i membri hanno di appartenere ed essere importanti gli uni per gli altri e per il gruppo e una fiducia condivisa nella possibilità di soddisfare i propri bisogni come conseguenza del loro essere insieme» (McMillan e Chavis cit.it Lavanco, Novara, 2002). Sul senso di appartenenza caratterizzato in questi termini influisce, inevitabilmente la natura del gruppo sociale al quale ci si riferisce.
I fenomeni di gruppo: differenze tra massa e gruppi e loro dinamiche.
La psicologia sociale ha mostrato sempre un interesse per i fenomeni di gruppo quali: il conflitto, la cooperazione, il conformismo, l’obbedienza. Nel percorso storico tracciato dai diversi esperimenti condotti, si possono ravvisare elementi fondanti che possono guidare la nostra analisi dei fenomeni di massa.
La massa è stata studiata, provando a darne una definizione, da Le Bon, il quale afferma che «ciò che più colpisce di una massa psicologica è che gli individui che la compongono-indipendentemente dal tipo di vita, dalle occupazioni, dal temperamento o dall’intelligenza- acquistano una sorta di anima collettiva per il solo fatto di trasformarsi in massa. Tale anima li fa sentire, pensare ed agire in un modo del tutto diverso da come ciascuno di loro- isolatamente- sentirebbe, penserebbe e agirebbe» (Le Bon, 1895).

Gli scritti di Le Bon contengono una tesi fondamentale: quando il soggetto si trova all’interno di un gruppo sociale allargato definito come “massa” modifica radicalmente il suo comportamento e agisce in maniera completamente diversa rispetto al proprio sentire o alla propria morale. La massa agisce sull’individuo depersonalizzandolo e prendendo il sopravvento.
Non risulta difficile leggere nelle definizioni di massa i risultati di quei movimenti sociali distruttivi come, ad esempio, il nazismo. Ma Le Bon scriveva molto tempo prima e nella sua mente c’erano i movimenti della rivoluzione francese o le sommosse civili che nel ‘700- ‘800 si svilupparono in tutta Europa. Tale fenomeno, fu studiato fino ad arrivare attorno il 1952 con una prima definizione di “deindividuazione” ad opera di Festinger, Pepitone e Newcomb (1952). Tale concetto consiste nella perdita del senso di individualità durante la quale il soggetto si comporta con poco o addirittura nessun riferimento rispetto ai valori personali interni o standard di condotta. Lo stato di deindividuazione è caratterizzato da uno stato di piacere dato dal sentirsi liberi di agire in base agli impulsi e senza nessun riguardo per le conseguenze delle proprie azioni.
In stretta correlazione con il concetto di deindividuazione, si trova quello di deresponsabilizzazione sociale legato all’obbedienza alle figure di autorità.
Milgram, fece un esperimento in cui si analizzava l’obbedienza di un soggetto ad un’autorità, dunque in quanto persona con un ruolo sociale specifico di tipo gerarchico. Tale esperimento avveniva mentre si processava il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann e ci si domandava se si poteva giustificare il comportamento omicida della persona come risultato dell’obbedienza ad una autorità.
La ricerca fu condotta nel 1961 da Stanley Milgram negli Stati Uniti e i partecipanti alla ricerca furono reclutati tramite un annuncio su un giornale locale o tramite inviti spediti per posta a indirizzi ricavati dalla guida telefonica. Il campione risultò composto da persone fra i 20 e i 50 anni, maschi, di varia estrazione sociale. Fu loro comunicato che avrebbero collaborato, dietro ricompensa, a un esperimento sulla memoria e sugli effetti dell’apprendimento.
Nella fase iniziale della prova, lo sperimentatore, assieme a un collaboratore complice, assegnava con un sorteggio truccato i ruoli di “allievo” e di “insegnante”: il soggetto ignaro era sempre sorteggiato come insegnante e il complice come allievo. I due soggetti venivano poi condotti nelle stanze predisposte per l’esperimento. L’insegnante (soggetto ignaro) era posto di fronte al quadro di controllo di un generatore di corrente elettrica, composto da 30 interruttori a leva posti in fila orizzontale, sotto ognuno dei quali era scritto il voltaggio, dai 15 V del primo ai 450 V dell’ultimo. Sotto ogni gruppo di 4 interruttori apparivano le seguenti scritte: (1–4) scossa leggera, (5–8) scossa media, (9–12) scossa forte, (13–16) scossa molto forte, (17–20) scossa intensa, (21–24) scossa molto intensa, (25–28) attenzione: scossa molto pericolosa, (29–30) XXX.
All’insegnante era fatta percepire la scossa relativa alla terza leva (45 V) in modo che si rendesse personalmente conto che non vi erano finzioni e gli venivano precisati i suoi compiti come segue:
- Leggere all’allievo coppie di parole, per esempio: “scatola azzurra”, “giornata serena”;
- ripetere la seconda parola di ogni coppia accompagnata da quattro associazioni alternative, per esempio: “azzurra – auto, acqua, scatola, lampada”;
- decidere se la risposta fornita dall’allievo era corretta;
- in caso fosse sbagliata, infliggere una punizione, aumentando l’intensità della scossa a ogni errore dell’allievo.
Quest’ultimo veniva legato ad una specie di sedia elettrica e gli era applicato un elettrodo al polso, collegato al generatore di corrente posto nella stanza accanto. Doveva rispondere alle domande, e fingere una reazione con implorazioni e grida al progredire dell’intensità delle scosse (che in realtà non percepiva), fino a che, raggiunti i 330 V, non emetteva più alcun lamento, simulando di essere svenuto per le scosse precedenti.
Lo sperimentatore aveva il compito, durante la prova, di esortare in modo pressante l’insegnante: “l’esperimento richiede che lei continui”, “è assolutamente indispensabile che lei continui”, “non ha altra scelta, deve proseguire”. Il grado di obbedienza fu misurato in base al numero dell’ultimo interruttore premuto da ogni soggetto prima che quest’ultimo interrompesse autonomamente la prova oppure, nel caso il soggetto avesse deciso di continuare fino alla fine, al trentesimo interruttore. Soltanto al termine dell’esperimento i soggetti vennero informati che la vittima non aveva subito alcun tipo di scossa.
I risultati stupirono perfino gli sperimentatori in quanto, nonostante i 40 soggetti dell’esperimento mostrassero sintomi di tensione e protestassero verbalmente, una percentuale considerevole di questi obbedì pedissequamente allo sperimentatore. Questo stupefacente grado di obbedienza, che ha indotto i partecipanti a violare i propri principi morali, è stato spiegato in rapporto ad alcuni elementi, quali l’obbedienza indotta da una figura autoritaria considerata legittima, la cui autorità induce uno stato eteronomico, caratterizzato dal fatto che il soggetto non si considera più libero di intraprendere condotte autonome, ma strumento per eseguire ordini. L’eteronomia è la percezione delle norme come provenienti dall’altro, in cui il soggetto non ha alcuno ruolo o possibilità di modifica. I soggetti dell’esperimento non si sono perciò sentiti moralmente responsabili delle loro azioni, ma esecutori dei voleri di un potere esterno. Alla creazione del suddetto stato eteronomico concorrono tre fattori:
- percezione di legittimità dell’autorità (nel caso in questione lo sperimentatore incarnava l’autorevolezza della scienza)
- adesione al sistema di autorità (l’educazione all’obbedienza fa parte dei processi di socializzazione)
- le pressioni sociali (disobbedire allo sperimentatore avrebbe significato metterne in discussione le qualità oppure rompere l’accordo fatto con lui).
Il grado di obbedienza all’autorità variava però sensibilmente in relazione a due fattori: la distanza tra insegnante e allievo e la distanza tra soggetto sperimentale e sperimentatore. Furono infatti testati quattro livelli di distanza tra insegnante e allievo: nel primo l’insegnante non poteva osservare né ascoltare i lamenti della vittima; nel secondo poteva ascoltare ma non osservare la vittima; nel terzo poteva ascoltare e osservare la vittima; nel quarto, per infliggere la punizione, doveva afferrare il braccio della vittima e spingerlo su una piastra. Nel primo livello di distanza, il 65% dei soggetti andò avanti sino alla scossa più forte; nel secondo livello il 62,5%; nel terzo livello il 40%; nel quarto livello il 30%.
Grazie all’esperimento, Milgram arrivò a dimostrare che l’obbedienza dipende anche dalla ridefinizione del significato della situazione: nel momento in cui il soggetto accetta la definizione della situazione proposta dall’autorità, finisce col ridefinire un’azione distruttiva, non solo come ragionevole, ma anche come oggettivamente necessaria.
Successivo all’esperimento di Milgram fu quello di Zimbardo che volle approfondire proprio il concetto di deindividuazione. Questo studioso nel 1971 alla Standford University condusse un esperimento che mirava a valutare l’ingerenza dell’assegnazione di un ruolo sul comportamento del singolo. Vale a dire che tale esperimento metteva in luce come l’appartenere ad un gruppo sociale influisse sul comportamento dei soggetti coinvolti anche se il ruolo era assegnato in modo arbitrario. Alla base dell’esperimento si trovano la teoria di Le Bon sul comportamento delle masse e il concetto di deindividuazione ivi contenuto. Nello specifico, suddivise i giovani studenti dell’università di Standford che avevano deciso di partecipare in “guardie carcerarie” e in “detenuti” e svolse un gioco di ruolo che doveva durare circa un mese in cui i partecipanti avrebbero vissuto nel seminterrato della stessa università. Fra i 75 studenti universitari che risposero a un annuncio apparso su un quotidiano che chiedeva volontari per una ricerca, gli sperimentatori ne scelsero 24, maschi, di ceto medio, fra i più equilibrati, maturi, e meno attratti da comportamenti devianti; furono poi assegnati casualmente al gruppo dei detenuti o a quello delle guardie. I prigionieri furono obbligati a indossare ampie divise sulle quali era applicato un numero, sia davanti che dietro, un berretto di plastica, e fu loro posta una catena a una caviglia; dovevano inoltre attenersi a una rigida serie di regole. Le guardie indossavano uniformi color kaki, occhiali da sole riflettenti che impedivano ai prigionieri di guardare loro negli occhi, erano dotate di manganello, fischietto e manette, e fu concessa loro ampia discrezionalità circa i metodi da adottare per mantenere l’ordine. Tale abbigliamento poneva entrambi i gruppi in una condizione di deindividuazione. L’esperimento venne interrotto dopo 5 giorni a causa degli eventi violenti e disastrosi messi in atto da guardie e prigionieri durante il gioco. Già dopo soli due giorni si verificarono i primi episodi di violenza: i detenuti si strapparono le divise di dosso e si barricarono all’interno delle celle inveendo contro le guardie; queste iniziarono a intimidirli e umiliarli cercando in tutte le maniere di spezzare il legame di solidarietà che si era sviluppato fra essi. Le guardie costrinsero i prigionieri a cantare canzoni oscene, a defecare in secchi che non avevano il permesso di vuotare, a pulire le latrine a mani nude. A fatica le guardie e il direttore del carcere (lo stesso Zimbardo) riuscirono a contrastare un tentativo di evasione di massa da parte dei detenuti. Al quinto giorno i prigionieri mostrarono sintomi evidenti di disgregazione individuale e collettiva: il loro comportamento era docile e passivo, il loro rapporto con la realtà appariva compromesso da seri disturbi emotivi, mentre per contro le guardie continuavano a comportarsi in modo vessatorio e sadico. A questo punto i ricercatori interruppero l’esperimento suscitando da un lato la soddisfazione dei carcerati, ma dall’altro un certo disappunto da parte delle guardie.
PERCEZIONE E COGNIZIONE
La modalità attraverso cui le persone giungono a costruire il mondo sociale sono le tematiche centrali dell’ambito di psicologia sociale detta social cognition.
In quest’ambito è stato dedotto che l’uomo si comporta come uno scienziato ingenuo, che cerca di comprendere fenomeni ed eventi esterni anche se non possiede gli strumenti adatti. Fiske e Taylor focalizzarono l’attenzione su queste scorciatoie di pensiero, dette euristiche. I modelli psicologici di riferimento sono essenzialmente quelli della gestalt (somiglianza, buona forma, coerenza) e del cognitivismo (maggiore peso ai dati obbiettivi rispetto alle conoscenze precedenti), e si ritrovano in una linea comune rispetto al modo di intendere i processi di percezione e categorizzazione sociale.
Secondo Bruner la percezione sociale interagirebbe con le categorie mentali, con le organizzazioni di informazioni presenti in memoria. Questo processo implicherebbe cioè un processo top-down (si partirebbe dalle conoscenze già possedute per arrivare al significato dei dati).
La categorizzazione sociale
Categorizzazione è un termine usato in psicologia (soprattutto in psicologia cognitiva) per descrivere il processo mediante cui noi raggruppiamo stimoli simili in categorie. Ad esempio oggetti rotondi con un picciolo in mezzo fanno parte della categoria frutta.
Il motivo della categorizzazione è che il mondo è talmente ricco di stimoli che se dovessimo comprenderli tutti in modo sparso impazziremmo. Quindi la mente fa una semplificazione raggruppandoli in categorie per facilitarne il riconoscimento. Ma il processo non si limita a stimoli inanimati, ma si estende anche a stimoli sociali. Noi raggruppiamo anche le persone in categorie. Marco fa parte della categoria “amici”. Il motivo è lo stesso degli stimoli inanimati: ci sono troppe persone nel mondo e dobbiamo raggrupparle per riconoscerle tutte.
La categorizzazione si basa su fattori come aspetto fisico di una persona(se una persona ha la pelle più scura della mia fa parte della categoria persone di colore), ma comprende anche i comportamenti di una persona(quella persona prega, quindi è della categoria “religiosi”.).
Le conseguenze della categorizzazione: spiegazione e pregiudizio
Il risultato della categorizzazione è che noi mettiamo in atto un processo che in psicologia sociale è chiamato spiegazione o “inferenza“. In sintesi, noi attribuiamo le cause di un comportamento di una persona al fatto che fa parte di quella specifica categoria. Altro effetto della categorizzazione è il pregiudizio. Il pregiudizio è un atteggiamento negativo o positivo nei confronti di gruppi di persone. .

Una variante del pregiudizio è la discriminazione. è un atteggiamento negativo, questa volta però verso singole persone e non verso gruppi
Le impressioni di personalità tra percezione e cognizione
Nel 1946 Solomon Asch pone le basi della social cognition, postulando che quando si osserva una persona o quando si ascolta la descrizione che ne viene fatta, l’impressione che se ne ricava non è il semplice risultato della somma delle caratteristiche osservate o di cui si ha notizia. Asch attraverso la sperimentazione diede la dimostrazione empirica a questa teoria, per cui dimostrò che il bisogno di formare un’immagine coerente della persona da valutare, fa sì che la semplice variazione di un tratto modifichi l’impressione della sua personalità nella sua interezza. Inoltre dai suoi esperimenti si è venuti a conoscenza che vi sono alcuni tratti che si pongono come centrali rispetto ad altri che invece sono periferici (per cui i tratti assumono significati diversi in base al contesto). Infine, è stato scoperto che anche l’ordine temporale con cui le informazioni vengono ricevute influenza fortemente la percezione e la valutazione della personalità di un soggetto (effetto primacy o effetto d’ordine). Si confermerebbe quindi il luogo comune “la prima impressione è quella che conta”.
Gli studi di Brunswik e Reiter portarono alla conferma dell’esistenza di alcuni schemi mentali che orientano in modo preciso le valutazioni sugli individui in base alla configurazione dei volti. Emerge così l’esistenza di alcune teorie implicite della personalità le quali fanno si che sia possibile andare oltre l’informazione data, togliendo alla vita sociale quella connotazione di caos che altrimenti avrebbe. Inoltre sembrerebbe che nel valutare gli altri saremmo guidati da una sorta di positività pregiudiziale che ci porterebbe ad attribuire alle persone caratteristiche più positive che negative (principio di Polianna).
Le teorie dell’attribuzione
Fritz Heider, già dal 1958, delinea quella che viene detta la teoria dell’attribuzione, la quale cercherebbe di dar conto del modo in cui le persone interpretano le ragioni degli avvenimenti del loro mondo sociale, ad esempio il motivo per cui tendiamo a vedere nelle persone caratteristiche che si mantengono costanti, al di là della mutevolezza del loro comportamento. Heider analizza poi l’importanza della situazione specifica in cui un certo comportamento è prodotto, al cambiamento del quale, noi attribuiamo una differente interpretazione al comportamento e quindi alla personalità di chi stiamo osservando.
Jones e Davis, successivi a Heider, sostennero negli anni sessanta, che gli individui quando devono giudicare le altre persone, si basano essenzialmente sul comportamento messo in atto spontaneamente, e che sono molto attenti ad individuare se sono intenzionali o meno. Se si produce un danno per un incidente, non si è giudicati malvagi, come invece accadrebbe se lo si facesse con intenzionalità. L’intenzione può inoltre suddividersi in due componenti principali: la conoscenza (sono cosciente di poter produrre un danno?) e la capacità (potrei evitare di produrlo?).
Jones e Davis si concentrarono quindi sull’individuazione delle intenzioni che spingono ad agire in un dato modo in una data situazione. Un modello di riferimento per valutare queste caratteristiche è quello della desiderabilità sociale. Ovvero, quanto più una persona si comporta secondo modi non desiderabili, tanto più probabilmente quei modi “negativi” ne caratterizzano la personalità. Cosa che non avverrebbe se si trattasse di casi isolati legati alla situazione specifica. Un altro modello è quello della libera scelta. Si tratta cioè di capire se un comportamento è prodotto perché chi lo compie ne sente autonomamente il bisogno oppure perché egli è indotto, in qualche modo, a farlo.
Heider fa dunque notare come uno dei modi con cui gli individui cercano di padroneggiare la realtà sociale è quello di cercare le cause che stanno dietro i comportamenti che osservano attraverso processi di attribuzione:
1. Il locus della causalità ( Locus of control), ovvero se le cause sono da rintracciare nella persona che ha prodotto il comportamento o nella situazione;
2. Stabilità / instabilità, ovvero se si tratta di caratteristiche interne stabili (personalità) o instabili (eccezionalità), o di cause esterne stabili (norme sociali) o instabili (fortuna, meteo, ecc.);
3. La controllabilità, ovvero se le cause sono controllabili o meno dall’individuo.
Tutti questi elementi configurano quindi un modello tridimensionale. Secondo Kelly (1967) per rispondere a questi quesiti applichiamo un vero e proprio metodo scientifico analizzando in che modo le cause covariano gli effetti.
Errori e giudizi tendenziosi nelle spiegazioni causali
I modelli di Jones e Davis e di Kelly assumono che gli individui utilizzano strategie cognitive di tipo razionale: partono da ciò che osservano per arrivare ad individuare le disposizioni stabili degli attori o rintracciare spiegazioni che siano a carico della situazione. Le ricerche condotte tra gli anni sessanta e settanta dimostrarono che il comportamento psicologico di ciascuno di noi è dedito ad errori sistematici dato che abbiamo la tendenza a cercare risposte che siano le più coerenti ma anche le più rapide possibili.
Jones e Richard E. Nisbett sottolinearono poi come siamo portati ad attribuire al nostro comportamento fattori situazionali e al comportamento degli altri, i fattori disposizionali. Questo modo sistematico di distorcere la realtà nell’interpretare il comportamento altrui, è stato chiamato da Ross “errore fondamentale di attribuzione”. Tale meccanismo sembrerebbe attivarsi in maniera del tutto automatica e inconscia, poiché ciascuno di noi è portato a prestare molta attenzione alla persone che mette in atto un dato comportamento e ad ignorare la situazione in cui questo viene prodotto.
Invece, nella comprensione dei propri comportamenti, l’individuo possiede molte più informazioni su sé stesso, pertanto sarebbe portato a osservare più l’esterno concentrandosi così più sulla situazione che sulla propria personalità. Vi è però anche una tendenza a incorrere in errori di giudizio sulla base di spinte motivazionali: il desiderio di considerare noi stessi positivamente fa si che si attivi un meccanismo (self serving bias di attribuzione) il quale ci fa attribuire i successi a nostre cause interne, mentre gli insuccessi alle cause esterne.
Il meccanismo del self serving bias si produce non solo per spiegare il proprio comportamento, ma esso si attiva anche per spiegare il comportamento degli altri in diversi contesti relazionali (ad esempio nella coppia si tende ad attribuire all’altro/a le colpe e a sé stessi i meriti). Lo stesso meccanismo poi viene utilizzato anche a favore dei propri gruppi di appartenenza (group serving bias) per cui i successi sarebbero dovuti ai membri del gruppo, mentre gli insuccessi ai fattori esterni.
La tendenza a percepire se stessi in termini favorevoli è rintracciabile anche in altri ambiti. Le persone infatti si reputano al di sopra della media (non capiterà a me quella sfortuna). Si tratterebbe di una sorta di ottimismo irrealistico correlato ad una forte illusione di invulnerabilità (io non ho bisogno di indossare le cinture di sicurezza).
La visione distorta del mondo avviene anche con l’idea comune che le altre persone debbano avere le nostre stesse opinioni (falso consenso) secondo meccanismi che pongono noi stessi al centro del mondo e che ci portano a generalizzare le nostre opinioni anche sugli altri individui. Sulla base di questo principio siamo poi portati a credere che nelle nostre abilità e successi siamo unici, mentre nelle nostre debolezze siamo simili a tutti gli altri (sono l’unico a pagare le tasse, non pago le tasse perché non lo fa nessuno), secondo un modello detto di “falsa unicità”.
Secondo Taylor e Brown questi atteggiamenti sono il frutto della selezione naturale per cui il self serving bias assicurerebbe una vita più serena e soddisfatta, favorendo così chi lo possiede. L’illusione del controllo è la diretta conseguenza di questi atteggiamenti, per cui ci sentiamo padroni del nostro destino e riteniamo responsabili gli altri delle nostre sfortune. Da questi presupposti si possono anche generare comportamenti negativi come quello di attribuire caratteristiche negative a gruppi emarginati, nell’idea che noi vivremmo in un mondo giusto (se sei povero è perché te lo meriti).
Le euristiche di giudizio
Le euristiche di giudizio (così chiamate da Tversky, Kahneman, Nisbett e Ross) sono le scorciatoie mentali le quali vengono utilizzate per prendere una decisione o esprimere una valutazione quando ci si trova in situazioni particolarmente complesse. Le euristiche possono essere di diverso tipo:
1. Euristica della disponibilità, quando viene emesso un giudizio sulla probabilità di frequenza di un evento (qual è il tasso disoccupazione? Anche se non disponi di informazioni necessarie per rispondere?);
2. Euristica della simulazione, quando dobbiamo emettere un giudizio sulle probabili reazioni di un’altra persona di fronte ad un evento (come reagirà papà alla bocciatura all’esame?);
3. Euristica della rappresentatività, ovvero la probabilità che una certa persona o un certo evento rientri in una data categoria (una persona timida, introversa e attenta, probabilmente sarà uno stuntman o un contadino?);
4. Euristica di ancoraggio, quando una serie di giudizi si avvicinano il primo (l’esaminatore inizia con un bravo allievo, sarà portato a trattare molto bene anche i successivi).
Schemi e categorizzazioni
L’insieme strutturato e organizzato di conoscenze di cui disponiamo quindi nei nostri giudizi, prende il nome di “schema”. Ad esempio, tutti possediamo degli schemi di eventi, dei veri e propri “copioni” che verranno utilizzati in date circostanze (al ristorante, ci sediamo, ordiniamo, mangiamo, paghiamo). Possediamo anche degli schemi di persone (da un individuo estroverso ci aspettiamo un comportamento piuttosto che un altro), e anche degli schemi del self (una persona che si ritiene indipendente ricorda tutti i momenti in cui si è comportato in questo modo). Vi sono poi gli schemi di ruolo (madre, padre, professore,ecc) attraverso i quali ci aspettiamo determinati comportamenti in base al ruolo svolto da un individuo. Zimbardo provò l’importanza degli schemi con l’esperimento che ricorda la trama del film The Experiment.

Abbiamo 4 tipi di schemi in psicologia sociale. Schemi di persone, di ruoli, di sé, di eventi e azioni.
Nelle nostre relazioni con gli altri siamo pure guidati da degli schemi, detti di gruppo (gli anziani, le donne, i giovani, ecc.) che danno così luogo agli stereotipi i quali sono così fissati nella nostra mente che resisteranno anche di fronte ad evidenti comportamenti contrari rispetto alle previsioni (in alcuni casi si creano dei sottogruppi per mantenere salde le basi dello stereotipo).
A guidare le nostre impressioni sugli altri interviene un meccanismo che pone al centro dell’attenzione la salienza (caratteristiche inusuali). È questo il caso per cui in un tram notiamo facilmente un extracomunitario in quanto “saliente” rispetto al resto degli individui.
Inoltre sarebbero le prime informazioni a far sì che si attivi uno schema piuttosto che un altro sulla base di quello che viene definito “effetto primacy”. Correlato a questo, esisterebbe anche un “effetto priming“”, il quale tiene conto dell’idea che ci si è fatti sulla base di caratteristiche parziali, l’interpretazione delle quali determineranno il giudizio complessivo anche dopo l’aver appreso le altre informazioni (se ho attivato uno schema positivo, elaborerò in senso positivo anche le successive informazioni e viceversa).
In sociologia esiste una legge detta della “profezia che si autoavvera” (se tutti pensano che la borsa crolla, essa crolla davvero). Lo stesso meccanismo avviene anche nei rapporti con le persone. Snyder, Tanke e Berscheid lo hanno dimostrato con degli esperimenti (chiedendo a dei ragazzi di telefonare a delle ragazze e facendogli credere che fossero particolarmente carine, entrambi i soggetti si comportarono di conseguenza, nonostante la realtà fosse differente). Vi è dunque negli esseri umani una tendenza a cercare di confermare le proprie ipotesi, processo che fa si che la credenza crei la realtà.
Gli atteggiamenti
Atteggiamenti, cambiamento e coerenza, cognitiva
Heider formulò la teoria dell’equilibrio cognitivo, secondo cui gli individui sono spinti da forze interne a tenere in equilibrio le proprie cognizioni relative ad un dato oggetto, o un gruppo di oggetti che siano legati gli uni con gli altri. Quando per qualche ragione tale equilibrio viene a mancare, le persone cercherebbero immediatamente di ripristinare una condizione di coerenza. Per queste ragioni le relazioni sarebbero costituite da una configurazione triadica formata da:
1. Un atteggiamento verso un’altra persona;
2. Un atteggiamento verso un oggetto;
3. La percezione del modo in cui l’altra persona valuta l’oggetto target.
Quindi se due persone hanno lo stesso atteggiamento verso lo stesso oggetto, stanno bene insieme, creando un “quadro” coerente dotato di buona forma.
Le situazioni squilibrate invece creano tensioni spiacevoli e le persone, per eliminare il disagio, cercano di riequilibrare il sistema .
Il passaggio da una condizione di squilibrio ad una di equilibrio avviene attraverso quello che viene detto “il principio dello sforzo minore”.
Le emozioni giocano poi un ruolo molto importante nel formulare un’idea su un individuo o un comportamento.
L’emozione che ci scaturisce da un dato comportamento produce, per un effetto di razionalizzazione, l’elaborazione di un’idea che ne sia correlata (se un dittatore commette una strage, noi lo disprezziamo o il nostro partner è buono e intelligente, perché ne siamo attratti).
A tal proposito Festinger sviluppò la teoria della dissonanza cognitiva, secondo cui l’incoerenza atteggiamento-comportamento è riconducibile a due situazioni: produzione di decisioni in regime di libera scelta e che siano contrari ai nostri atteggiamenti (comportamenti contro-attitudinali). È il caso della scelta tra un lavoro noioso ma ben ricompensato, oppure uno piacevole ma economicamente precario. Qualsiasi sia la scelta finale tenderemo a massimizzare i lati positivi e a minimizzare quelli negativi, convincendoci infine, di aver fatto la scelta giusta.
Festinger e Carlsmith provarono, attraverso degli esperimenti, come il mutamento delle proprie convinzioni avvenga più facilmente ricevendo una ricompensa piccola piuttosto che una grande. Il principio regge sul fatto che una grande ricompensa possa condurre un comportamento contrario alle proprie attitudini, ma noi non cambieremmo le nostre attitudini. Invece se supportati da una piccola ricompensa saremo portati a credere che se abbiamo commesso un comportamento per “cosi poco”, evidentemente lo approviamo. Allo stesso modo, la piccola punizione sarà più efficace della grande punizione (è il caso della buona educazione a cui consegue una interiorizzazione delle norme sociali).
Si pone dunque centrale, la quantità di libera scelta che l’individuo possiede o pensa di possedere nel esprimere un determinato comportamento. Ulteriori elementi che producono un cambiamento dei propri atteggiamenti sono le conseguenze (previste o prevedibili) e l’irrevocabilità. Per cui dopo aver preso una decisione, sulla quale non si potrà tornare indietro, e/o che abbia prodotto delle conseguenze negative, saremo portati a legittimare il comportamento ormai eseguito.
.
.

Cos’è il workaholism
La sindrome da burnout: cos’è, come si manifesta e come affrontarla
STRESS E COPING
Cosa sono il Mobbing e lo Straining
Il Minnesota Starvation Experiment (M.S.E.)
Cos’è la peer education
IL CYBERBULLISMO
I GRUPPI DI AUTO-AIUTO
Expertimenter: Il film sull’esperimento di Stanley Milgram
L’esperimento di Stanley Milgram: VIDEO
L’esperimento di Stanley Milgram: l’obbedienza alla autorità
L’esperimento di Philip George Zimbardo alla prigione di Stanford
Una introduzione alla teoria sociale cognitiva di Albert Bandura (video)
Albert Bandura, Leading Psychologist of Aggression, Dies at 95 – The New York Times