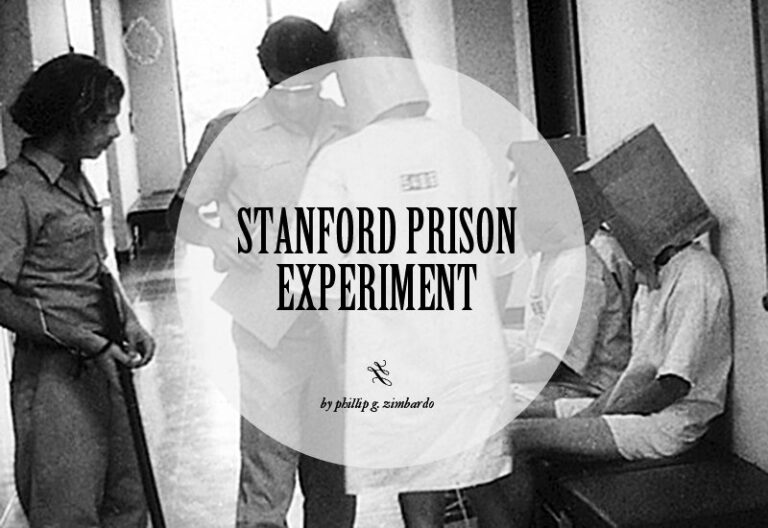Influenza sociale e conformismo
Dal conformismo all’obbedienza distruttiva
Per influenza sociale si intendono quei cambiamenti che si verificano nei giudizi e nelle opinioni quando un individuo si trova esposto a giudizi e opinioni altrui. Il conformismo implica l’essere influenzati da ciò che fanno gli altri fino al punto di fare volontariamente delle cose, che non si farebbero se si fosse da soli. Si parla invece di interiorizzazione delle norme del gruppo, quando accediamo ai giudizi e ai comportamenti altrui per giustificare i nostri. Può inoltre accadere che ci conformiamo agli altri perché ce l’hanno chiesto (conformismo pubblico), o perché non potevamo fare altrimenti (acquiescenza, obbedienza a chi riteniamo abbia l’autorità per imporci un dato comportamento). In ogni caso, gli esseri umani, con solo la loro compresenza si influenzano a vicenda incidendo sui nostri comportamenti.
L’influenza sociale sulla prestazione
Norman Triplett fu il primo a trovare risposte scientifiche al fenomeno dell’influenza sociale (esperimento del lavoro di gruppo). Zajonc introdusse poi un principio fondamentale nella materia, basandosi sulla teoria delle pulsioni di Hull-Spence. Secondo Zajonc, il pubblico, con la sua sola presenza crea negli individui uno stato di eccitazione che avrebbe come conseguenza un’attivazione della prontezza a rispondere. L’influenza sociale viene poi distinta in base ai possibili effetti che essa può avere:
effetto di facilitazione (competizione tra più individui su compiti risolvibili);
effetto inibizione (compiti difficili, che è più facile risolvere da soli).
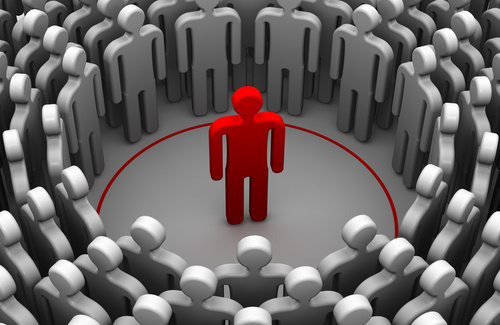
Inoltre, quando si è molto preparati sull’azione da compiere, il pubblico ha un effetto di facilitazione (sostenere un esame, fare una partita, ecc., sapendo di esserne capaci); al contrario, quando non ci si sente preparati, si teme il giudizio del pubblico e si ha un effetto inibitorio.
Tuttavia, secondo Cottrell, l’avere delle persone che ci osservano, ci rende apprensivi e ci attiva in quanto vogliamo fare una bella figura in pubblico (si tratterebbe quindi di una risposta appresa e non innata). Baron aggiunse poi il principio per cui l’eccitazione sarebbe dovuta al conflitto, che scaturirebbe dalla presenza di un pubblico, tra la motivazione a prestare attenzione al giudizio del pubblico e quella di prestare attenzione al compito.
Un gruppo non solo aumenta la prontezza d’azione dei singoli, ma spesso porta anche alla perdita del senso di responsabilità individuale, a seguito di un fenomeno che Bon chiamo “di contagio sociale”. Festinger, Pepitone e Newcombe definirono questo fenomeno come de-individuazione, processo che porterebbe alla perdita dei freni inibitori e alla forte identificazione con gli scopi e le azioni del gruppo, con l’idea che la responsabilità sia diffusa pertutto il gruppo. Ringelmann fu il primo a descrivere il fenomeno dell‘inerzia sociale, attraverso alcuni esperimenti dimostrò che vi è una relazione inversamente proporzionale tra il numero di persone che compongono il gruppo e la prestazione dei singoli e che il risultato collettivo equivale a circa la metà della somma dell’impegno di ciascuno (se fosse solo). Egli interpretò questo fenomeno in termini di perdita o di mancanza di coordinazione. Stroebe e Frey aggiunsero che alla perdita di coordinazione si aggiunge la perdita della motivazione, secondo quello che viene detto “effetto free-rider”. Quindi l’influenza degli altri si esprime in termini di facilitazione sociale, la quale porta ad un miglioramento delle prestazioni se si tratta di compiti facili o prove in cui sono molto preparati. Quando invece le persone fanno parte di un team dove i loro sforzi individuali non possono essere o non sono valutati, scatta l’effetto Ringelmann e il gruppo ha un impatto in termini di indolenza sociale.
L’influenza della maggioranza

Conformarsi a quello che gli altri pensano o fanno è una risposta adattiva che permette al gruppo di mantenersi coeso, consentendo la formazione delle norme sociali. Può però diventare un meccanismo disadattivo se tarpa le capacità critiche individuali.
La formazione delle norme sociali
Quando gli individui interagiscono all’interno di un gruppo, finiscono con l’influenzarsi pesantemente l’un l’altro fino a convergere, venendosi così a formare un atteggiamento conformista che fa sa sfondo all’affermazione delle norme sociali. Sherif dimostrò che l’interazione sociale porta le persone a fare confluire i loro punti di vista in una norma
comune condivisa, pertanto, uniformarsi ad essa dà la possibilità di usufruire in maniera rapida di tali conoscenze e consente di affrontare senza rischi eccessivi le difficoltà della vita sociale.
Il conformismo e il paradigma di Asch
Il paradigma di Asch, elaborato negli anni cinquanta, a seguito di una serie di esperimenti, postula che con una media di una su tre, la risposta data da un individuo a una domanda è conformata alla risposta data dalla maggioranza, anche quando si crede che non abbia ragione.
Le ragioni del conformismo
Asch prova quindi che la gente si conforma a quello che pensano gli altri anche se questo è in palese contrasto con la propria percezione del mondo (soprattutto di fronte a un pubblico). Le ragioni del conformismo risiederebbero nelle risposte che ognuno si da a due domande che tutti ci poniamo prima di esprimere un giudizio di fronte agli altri: la mia opinione è corretta? Gli “altri” ci approvano? Accettare il giudizio degli altri significa accettare implicitamente l’ipotesi che gli altri abbiano più informazioni di noi. Viene definita pressione informazionale, quella che fa si che gli individui accettino le opinioni del proprio gruppo. Un ulteriore motivo per cui conformarsi risiede nel bisogno di piacere e di essere accettato (pressione normativa). Nel primo caso (problema di informazione) cambieremo le nostre opinioni in maniera profonda; nel secondo caso invece (norme sociali), solo superficialmente.
Più un gruppo è coeso, più i suoi membri tenderanno a mantenere saldi (conformandosi) i valori e le norme sociali.
La grandezza del gruppo è anche determinante, Asch provò che un numero inferiore a tre membri, sarebbero troppo poco, e al contrario, superiore a quindici membri sarebbero in troppi.
L’influenza della minoranza e la conversione
La minoranza può effettivamente cambiare le posizioni della maggioranza (come la storia umana insegna). La forza persuasiva della minoranza è da rintracciare nello stile di comportamento che essa utilizza, la cui componente più importante è la coerenza (sia a livelli intraindividuali, sia interindividuali). A queste condizioni si potrà avere un cambiamento di opinioni nella maggioranza (conversione). Al contrario dell’influenza della maggioranza, la minoranza quando incide, incide molto profondamente negli individui. Questo perché la minoranza stimola un processo di validazione, ovvero un processo cognitivo che porta a trovare le ragioni che fanno si che la minoranza mantenga nel tempo le sue posizioni in maniera coerente.
Inoltre, Nemeth ha fatto notare che la minoranza induce un’attivazione mentale che va oltre quello che essa vuole (pensiero divergente), al contrario ella maggioranza (pensiero convergente).
I processi decisionali all’interno dei gruppi
In genere si crede che i gruppi siano più in grado degli individui nel prendere delle buone decisioni, dato che i gruppi possiedono maggiori informazioni. In realtà, secondo gli esperimenti di Sherif, si verificherebbe solo un effetto normalizzazione, il quale da conto del comportamento delle persone quando si trovano ad emettere un giudizio personale all’interno di un gruppo (decisione individuale) , ma non da conto dei processi di presa di posizione di gruppo (decisione collettiva).
Stoner, negli anni sessanta, provò che i gruppi non prendono affatto decisioni più moderate dei singoli, anzi è vero il contrario, si verificherebbe un fenomeno detto dello “spostamento verso il rischio”. Qualunque sia il tema della discussione, i gruppi tendono a spostarsi dunque verso posizioni estreme, nella direzione verso cui, in media, i singoli sono già orientati (polarizzazione di gruppo). La polarizzazione da conto, in pratica, del rafforzamento dovuto alla discussione di gruppo, di una posizione che era già dominante (anche se inespressa). Le spiegazioni di questo processo possono essere la maggiore disponibilità di informazioni (influenza informazionale) o il desiderio di dare un’impressione positiva che spinge i membri a seguire quelli più temerari o coraggiosi (pressioni normative).
Janis descrisse il caso di estrema polarizzazione di gruppo, processo che può portare a decisioni completamente sbagliate a causa di una sensazione di invulnerabilità data dalla forte coesione del gruppo. Questo tipi di gruppi è caratterizzato dalla presenza di un leader.
L’influenza sociale dell’autorità e l’obbedienza distruttiva
Gli esseri umani, attraverso i processi di socializzazione all’interno e all’esterno della famiglia, apprendono ad obbedire a chi ha l’autorità per farlo. L’obbedienza ha alla sua base, la consapevolezza che chi detiene legittimamente il potere ha l’autorità e il diritto di chiederci di obbedire.

Negli anni sessanta, Milgram condusse una serie di esperimenti che portarono alla scoperta della “obbedienza distruttiva” (far somministrare ad un individuo, shock elettrici da parte di un altro individuo, fino alla sua ribellione, qualora si verificasse).
Attraverso questi esperimenti Milgram provò che l’autorità legittima può indurre qualsiasi persona normale a mettere in atto crimini distruttivi. La spiegazione risiede nel fatto che siamo abituati ad obbedire chi ha autorità, quindi se questa autorità ha fini malvagi sarà difficile per noi opporci. Gli esperimenti misero poi in luce che la distanza sia fisica che emotiva dalla vittima fosse una variabile importante (non vedere la vittima fa aumentare la disponibilità ad obbedire; la presenza fisica dell’autorità induce a maggiore obbedienza; il comportamento degli altri determina maggiore o minore obbedienza; infine, grande importanza risiede nella percezione della propria responsabilità – mi è stato ordinato di farlo, io eseguo solamente l’ordine).
L’interazione nei gruppi
Cosa è un gruppo
Si parla di gruppo quando gli individui che ne fanno parte hanno per lo meno la potenzialità di avere tra di loro delle interazioni, e quando tra i membri vi è un’interdipendenza. Quindi non è la somiglianza o la diversità che decide se due individui appartengono allo stesso gruppo, ma l’interazione sociale. Secondo Lewin non è rilevante la grandezza del gruppo, ma la sua articolazione, pertanto occorrerebbe utilizzare modelli in scala ridotta dei gruppi sotto esame.
Le definizioni di Lewin però sono molto restrittive e portano a considerare solo gli aspetti principali dei gruppi, tralasciando tutte le altre interazioni minime (per Lewin, i viaggiatori di un aereo non costituiscono un gruppo). Non sono da intendere gruppi le categorie sociali (donne, bambini, pensionati, ecc.), ne il pubblico o la folla. Sono invece gruppi i team, le squadre, i gruppi di lavoro, la famiglia, le istituzioni (scuola, chiesa, ecc.).
La struttura del gruppo
I gruppi sociali sono quindi distinguibili per grandezza (anche una coppia di fidanzati è un gruppo) e durata (in una famiglia entrano nuovi membri, mentre altri si perdono), per scopi e valori. La struttura sociale di ogni gruppo si basa sul fatto che ogni membro abbia al suo interno uno status, ovvero una posizione più o meno duratura, lungo una scala gerarchica. Secondo la teoria delle aspettative circa lo status, questa collocazione avviene a seguito di quelle che sono le aspettative del gruppo circa le capacità e le competenze dei singoli membri. In alcune organizzazioni lo status e i ruoli sono espliciti e definiscono in maniera chiara i comportamenti possibili. A seguito di questa organizzazione, vengono create anche delle norme sociali a cui tutti devono attenersi. Levine e Moreland individuarono alcuni ruoli fissi, tipici di tutti i gruppi: il nuovo arrivato (da cui ci si aspetta che sia conformista); il capro espiatorio; il leader (che svolga due funzioni principali: far procedere il gruppo in armonia; che sia centrato sul compito nell’interesse del gruppo).
La leadership

Gli studi di Bales e Slater confermarono l’importanza di entrambe le funzioni nella personalità del leader, ma che allo stesso tempo è molto raro che questo avvenga. Di solito, infatti, i leader svolgono solo la funzione socio-emozionale (leadership democratica) o quella di essere centrati sul compito (leadership autoritaria).
La Hold scoprì che già nei gruppi di bambini la struttura del gruppo porta all’emergere di un leader, che di solito è colui che più protegge gli altri, prende iniziative, organizza giochi, distribuisce risorse e che sia più inventivo. Merei aggiunse che quando i bambini sono introdotti in un nuovo gruppo, preesistente, diventerebbero leader quei bambini che all’inizio riescono ad adattare il proprio comportamento e che solo in seguito propongono dei cambiamenti o delle innovazioni. Questo insieme di caratteristiche è presente anche nei gruppi di persone in età adulta (più intelligenti, capacità di gestire i rapporti; motivati e pronti ad assumersi responsabilità). Infine, sembrerebbe che sono le persone che più riescono a riscuotere fiducia, a diventare leader (carisma).
Tutte queste caratteristiche sono necessarie ma nessuna è sufficiente, anche perché la scalata sociale dipende dall’incrocio di questi elementi e dalla situazione. Fiedler, nel suo modello della contingenza ha infatti dimostrato che una leadership efficiente è il risultato dell’incrocio tra lo stile del leader e il controllo che questo ha sulla situazione. Il controllo è dato dalla qualità delle relazioni con gli altri membri; la chiarezza degli scopi e delle soluzioni; del livello di potere in termini di possibilità di distribuire premi e punizioni. Sia nel caso di un basso controllo, che di alto controllo della situazione, lo stile più efficiente è quello orientato verso il compito, mentre lo stile socio-emozionale è più efficace in situazioni di controllo moderato.
Se è vero che un leader può influenzare i membri del gruppo, è anche vero che egli viene influenzato dalle aspettative che il gruppo ha (se un leader non si comporta come il gruppo vorrebbe, può essere spodestato).
Hollander notò che un leader viene legittimato se viene scelto dall’interno (e non imposto dall’esterno); se, nelle fasi iniziali si sa conformare al gruppo; sa mostrare le abilità necessarie al raggiungimento degli scopi; sa identificarsi con il gruppo.
La situazione gioca un ruolo talmente rilevante, nella selezione del leader, che è necessario capirne il meccanismo per cui, ad esempio, chi si trova (o si sa piazzare) in una posizione centrale, favorevole alla comunicazione con tutti, può contare su una maggiore quantità di informazioni e pertanto acquisisce più probabilità di divenire leader.
L’identità sociale: dall’ingroup all’outgroup
Il gruppo costituisce un’unità con una sua identità sociale complessiva, il che determina che ogni membro si aspetta dagli altri, determinati comportamenti. Questa identità sociale complessiva è quindi legata all’identità sociale personale dei membri. La nostra identità è infatti, in larga parte funzione della nostre appartenenze ai vari gruppi sociali. Quindi, le nostre autodescrizioni saranno sempre composte da un mix di definizioni personali versus definizioni di gruppo (se facciamo parte di gruppi dominanti, verremo percepiti soprattutto per le nostre caratteristiche individuali; se facciamo parte di gruppi dominati, saremo percepiti prevalentemente nei termini di appartenenza al gruppo). Già Mead aveva sottolineato che l’identità si fonda sull’appartenenza ad un gruppo, ma si deve a Tajfel, la teoria dell’identità sociale. Egli richiamò l’attenzione sul dato che gli esseri umani hanno una propensione a base innata a raggruppare le persone in categorie sociali sulla base di specifiche dimensioni quali, sesso, razza, etnia, età, professione, religione. Pertanto il self è costituito dal miscuglio di identità sociali ai quali ciascuno appartiene. Si distinguono poi, due tipi di gruppi: primari (sono il fidanzato di…, faccio parte della famiglia…, sono il figlio di…) e secondari (sono italiano, sono uno studente, sono cattolico). I processi cognitivi di categorizzazione sociale e di autocategorizzazione, inducono ad esagerare al massimo la similarità all’interno dei gruppi, e la differenza tra gruppi (gettando le basi per la nascita di stereotipi).
Dunque il gruppo esterno, a causa dell’effetto omogeneità del gruppo esterno, ci appare costituito da individui pressappoco tutti uguali. Motivi principali di questa nostra miopia sono: (1) maggiori informazioni sui membri del proprio gruppo e minore su quelli del gruppo esterno; (2) prestiamo meno attenzione ai membri dei gruppi che riteniamo meno interessanti; (3) L’impossibilità di interazione potrebbe essere anche dovuta alla situazione obbiettiva; (4) in ogni caso, la semplice divisione in gruppi, anche arbitraria e basata sul niente, produce una doppia visualizzazione della realtà (eterogeneità/omogeneità) da parte dei membri.
L’identità sociale, i processi di autocategorizzazione in termini di noi inducono in maniera speculare, una sorta di effetto assunzione di similarità, che ci fa ritenere che condividiamo molti gusti e opinioni di chi appartiene al nostro gruppo. I membri del proprio gruppo, inoltre, vengono visti come dotati di caratteristiche più gradevoli rispetto ai gruppi estranei. Opererebbe dunque un pregiudizio funzionale al mantenimento di una buona immagine del gruppo di appartenenza, simile a quello che opera a livello personale (self serving bias). Allen provò che, delle persone raggruppate in base alle preferenze artistiche, pensavano di condividere con gli altri membri del gruppo anche altre caratteristiche. Per due scopi poi, che parole prive di significato vengono considerate positive se si associavano a “noi” e negative se si associavano a “loro”. Taylor e Jaggi, provarono infine, che se una stessa azione si attribuisce ad un membro di un gruppo estraneo, la si giudica più negativa, di un’azione attribuita a un membro del proprio gruppo.
Considerare il proprio gruppo migliore degli altri contribuisce quindi a costruire e a mantenere un’identità sociale positiva che influenza il nostro livello di autostima e l’immagine che abbiamo di noi stessi.
Stereotipi e pregiudizi: processi di categorizzazione e dinamiche relazionali

Fu il giornalista Lippman a suggerire il termine stereotipo per indicare quel tipo di semplificazione rigida che facciamo della realtà e che è ravvisabile nell’opinione pubblica.
Gli stereotipi sono rappresentazioni mentali che emergono da raggruppare gli individui sulla base dei fattori che li accomunano, tralasciando quelli che li rendono unici.
Sono quindi, quelle rappresentazioni cognitive che più risentono dell’effetto omogeneità del gruppo esterno e dell’effetto presunta similarità del gruppo interno. Sono, in sintesi, l’effetto collaterale e degenerato di quei processi cognitivi di autocategorizzazione e di categorizzazione sociale. Katz e Braly, con le loro ricerche fecero emergere che non solo esiste una grande condivisione nell’ingroup, ma anche che le persone tendono a delineare profili dei gruppi esterni come molto omogenei al loro interno. Queste valutazioni, per lo più negative, fanno si che una persona venga giudicata per la sua appartenenza ad un gruppo e non per quello che è in quanto individuo.
Gli stereotipi implicano un processo di discriminazione il quale si articola in comportamenti contro il gruppo verso il quale si nutre pregiudizio e di discriminazioni a favore del proprio gruppo. Vi è quindi una spinta all’etnocentrismo che fa percepire i valori del proprio gruppo di appartenenza come i più validi e condivisibili.
Gli stereotipi comunque, non sono del tutto arbitrari, ma hanno alla loro base le esperienze che facciamo nella nostra vita, per cui è possibile parlare di un “nocciolo di verità”. Smith e Mackie fecero notare che gli ebrei vengono considerati scaltri e avari perché dal Medioevo in poi una delle poche occupazioni alla quale avevano accesso era prestare denaro. Così, con il tempo, gli ebrei hanno finito per essere visti come particolarmente adatti a questa occupazione. In ogni società, peraltro, può essere rintracciato uno stereotipo comune. Di solito il gradino socioeconomico più basso viene considerato pigro, ignorante, sporco, immorale (negli USA è valso prima per gli irlandesi, poi per gli italiani, poi i portoricani, poi i messicani, ecc). I ruoli sociali spiegano, per lo meno in parte, anche gli stereotipi di genere, quelli che portano a considerare le donne sensibili, emotive, tenere, ecc. Inoltre, grande importanza è data alla situazione, per cui, i tedeschi durante la guerra venivano considerati crucchi e spietati, mentre in tempo di pace, efficienza e rigorosità.
I ruoli sociali di un gruppo limitano e delimitano i comportamenti che vengono messi in atto dai suoi membri.
Attraverso un meccanismo cognitivo che viene detto errore di corrispondenza, infatti, i comportamenti associati ai ruoli vengono attribuiti a caratteristiche di personalità dei singoli individui che appartengono a quel gruppo. Il processo che porta alla formazione di uno stereotipo è il seguente: (1) fattori sociali, economici politici e storici creano i ruoli sociali; (2) a gruppi diversi vengono assegnati ruoli diversi; (3) I membri dei gruppi assumono comportamenti appropriati al loro ruolo; (4) a causa dell’errore di corrispondenza, i comportamenti associati ai ruoli vengono attribuiti a caratteristiche di personalità dei singoli; (5) si forma lo stereotipo. Questo non vuol dire però che gli stereotipi non possano riflettere anche quelle che sono le caratteristiche reali di un particolare gruppo. Ma quando si parla di propensioni a base innata, si parla di tendenze medie di una popolazione, mentre gli stereotipi diventano pericolosi perché attribuiscono a tutti i membri di quel dato gruppo, le caratteristiche medie. Pertanto, nel momento in cui le nostre valutazioni di un gruppo o di un individuo si basano sui due seguenti tipi di sillogismo: (1) le donne sono emotive, Federica è una donna, quindi è emotiva; oppure Federica è emotiva, Federica è una donna, quindi le donne sono emotive, siamo in entrambi i casi vittime di stereotipi distorti.
Quindi gli stereotipi hanno le stesse conseguenze degli schemi, ovvero, le informazioni nuove che non siano in linea con lo stereotipo vengono con facilità rifiutate o dimenticate. Le informazioni ambigue vengono invece interpretate in modo da essere congruenti con l’immagine mentale che si ha di un certo gruppo. Sagar e Schofield scoprirono negli anni ottanta, che lo stereotipo della “razza” guida l’interpretazione degli eventi già in età precoce. (i bambini bianchi e neri interpretavano razzisticamente delle immagini anonime su cui potevano inventare una storia).
Peraltro, come tutti gli schemi, gli stereotipi possono spingere coloro che fanno parte del gruppo esterno a mettere in atto proprio quei comportamenti che confermano lo stereotipo. Lo stereotipo si pone quindi in termini di “profezia che si auto-avvera”.
Quindi, l’auto-consapevolezza di far parte di una minoranza, di essere diversi, porta a percepire gli altri come pronti a reagire alla propria diversità, anche quando in effetti questo non sta accadendo. Kleck e Strenta, negli anni ottanta hanno dimostrato che la consapevolezza di essere portatori di un difetto fisico altera la percezione degli altri nei propri riguardi (disegnarono finte cicatrici sui volti di alcune “cavie”, ma prima di farle andare in giro, cancellarono di nascosto queste cicatrici. Quindi una volta andati in giro per la città, pensarono di essere osservati in maniera particolare, anche se in realtà non avevano nessuna anomalia). Gli stereotipi sono quindi il lato oscuro dei nostri processi di categorizzazione sociale.
Nei nostri processi di elaborazione delle informazioni siamo portati a prestare più attenzione a quelle che sono le caratteristiche insolite, salienti degli individui, e a trascurare le informazioni relative a ciò che è comune. Per un meccanismo cognitivo che è stato scoperto da Loren e Jean Chapman, siamo portati a ritenere che se due eventi insoliti, poco frequenti e pertanto distintivi, si verificano per alcune volte allo stesso tempo, questi sarebbero correlati tra loro. Questo effetto di condivisione di distintività, definisce una correlazione illusoria (se avviene un borseggio, e tra i presenti c’è un nero, si tende a pensare che sia egli il colpevole). Quindi, quando in un gruppo qualcuno è molto visibile, e cattura la nostra attenzione (salienza), tendiamo a vederlo come responsabile di quello che succede.
I mass media, nel riportare di delitti e atti delinquenziali, riflettono proprio questo fenomeno e lo amplificano. Il risultato di questo modo di presentare gli eventi è quello di creare una correlazione tra i due fenomeni e far sì che si rafforzi nell’immaginario della popolazione, lo stereotipo che gli omosessuali o i malati di mente o gli extracomunitari, siano violenti, immorali e irresponsabili, senza differenza per i membri di quei gruppi.
L’approccio motivazionale e dinamico alle relazioni interetniche e al pregiudizio
Se è vero che spesso gli stereotipi sono il frutto della storia e delle società, è anche vero che è possibile nutrire pregiudizi anche nei confronti di gruppi dei quali non si sa assolutamente nulla. Il solo percepire una persona come appartenente ad un altro gruppo, porta infatti, a sentimenti di diffidenza e di ostilità.
È possibile, tuttavia, rintracciare anche altre motivazioni alla messa in atto di comportamenti pregiudiziali. Hovland e Sears, negli anni quaranta, trovarono la correlazione tra le crisi economiche negli USA e l’aumento del numero di linciaggi impartiti alle minoranza. Dimostrarono cioè il collegamento tra frustrazione e aggressività, per cui si vengono a produrre dei capri espiatori a cui attribuire le cause dei propri fallimenti. Tuttavia, la teoria del capro espiatorio ha dato esiti diversi nella sua sperimentazione: Miller e Bugelski trovarono che effettivamente ci fosse un collegamento tra la frustrazione e la ricerca di un capro espiatorio; Leonard e Berkowitz invece, trovarono che non necessariamente il comportamento aggressivo conseguente alla frustrazione, avesse per target coloro verso cui si aveva un atteggiamento pregiudiziale.
Il “Gruppo di Bereley” percorse lo studio del pregiudizio in un’accezione ben più ampia. Partirono dall’ipotesi che il pregiudizio sia essenzialmente un problema di personalità, secondo un’ottica freudiana, sostennero che il modo in cui un individuo viene allevato dai suoi genitori nelle prime fase dello sviluppo, da luogo a caratteristiche di personalità diverse che possono portare a potenziali esiti di tipo pregiudiziale. (i genitori troppo severi producono un accumulo di energia che il figlio non potrà scaricare su di loro, e che pertanto sarà portato a scaricare sugli individui che riterrà più deboli, più inferiori. Si parla di formazione della personalità autoritaria, dedita al pregiudizio, che sarebbe l’effetto collaterale di una personalità distorta.
L’aggressività
L’aggressività e l’altruismo rappresentano il polo positivo e il polo negativo del comportamento umano. Entrambe possono essere interpretate in maniera differente in funzione dei diversi modelli di riferimento; ed entrambe vanno valutate all’interno di un approccio multi-dimensionale che tenga conto dei fattori che ne “influenzano la messa in atto”, “le caratteristiche di chi produce l’azione”, “le caratteristiche del target”, e quelle della “situazione” in cui si manifestano.
Definire l’aggressività
Affinché si possa parlare di aggressività occorre che vi sia l’intenzione di procurare un danno. Proprio dall’interpretazione che gli individui fanno di una aggressione altrui, elaborano la risposta più consona. Inoltre, per comportamento aggressivo si intende tutto ciò che danneggia intenzionalmente un altro, non necessariamente dal solo punto di vista fisico (anche l’insulto è un’aggressione).
Espressioni dell’aggressività e motivazioni sottostanti

Definire cosa è aggressione non può prescindere dall’individuazione delle varie forme che assume e dalle varie motivazioni sottostanti. Attili e Hinde individuarono due tendenze, una ad essere assertivo e una ad essere violento.
Infatti, i diversi tipi di violenza sono riconducibili a sistemi ormonali e neuronali differenti: (1) Aggressione strumentale (per guadagnare qualcosa, premeditando l’azione); (2) Aggressione ostile (con lo scopo di far del male, ferire o logorare l’altro); (3) Violenza emotiva, impulsiva (sotto l’influsso della rabbia, a caldo, non premeditata); (4) La violenza difensiva o ritorsione (scatenata dalla percezione, reale o presunta, di una provocazione). Queste prime categorie sono quelle principali alle quali sono stati ricondotti gran parte delle violenze osservate dagli studiosi.
Tuttavia esistono anche categorie più specifiche come, (5) la violenza criminale (omicidio commesso da un ladro sorpreso a rubare); (6) la violenza dissociale (attuata per una sottomissione al proprio gruppo, tipica dei mafiosi); (7) la violenza bizzarra (crimini di tipo psicopatico).
Le teorie dell’aggressività e i rapporti individuo-società
Quando si parla di aggressività bisogna tenere in considerazione due modelli contrapposti del comportamento umano: le componenti istintive ed innate e quello dei fattori sociali, ambientali ed educativi. Che l’uomo sia per natura aggressivo è un postulato su cui sono d’accordo sia in psicoanalisi, sia nella psicologia influenzata dall’etologia. Freud sostenne che gli esseri umani sono guidati da istinti sessuali e aggressivi, e fece notare che tali istinti hanno bisogno di essere controllati e regolati mediante la formazione di norme sociali con le quali sono in eterno contrasto. Ma se la repressione della sessualità e dell’aggressività ad opera degli insegnamenti, delle punizioni e dell’educazione, costituiscono una vera e propria condizione perché la società sopravviva, diventa essa stessa fonte di ulteriore aggressività per la frustrazione che ne deriva e la conseguente reazione che innesca. Lorenz sostenne che il comportamento aggressivo è frutto di un istinto incontrollabile, e ritenne, d’accordo con Freud, che l’aggressività sia dovuta al formarsi, nell’individuo, di un accumulo di energia che cerca di defluire all’esterno appena la situazione lo permette. La spiegazione di questo assunto starebbe ne fatto che ai primordi della specie, gli individui più aggressivi furono più avvantaggiati, facendo così ereditare, mediante selezione naturale, la spinta ad essere violenti.
Secondo questa interpretazione negativa, una soluzione è quella dello sport.
Secondo i comportamentisti e la social learning theory, la visione del fenomeno è opposta, essi pongono infatti l’enfasi sulle influenze sociali, all’imitazione, all’assistere alla violenza, all’impossibilità di raggiungere i propri scopi.
Secondo questa visione quindi, l’individuo nasce come una tabula rasa sulla quale agiranno un sistema di rinforzi positivi e negativi che ne plasmerà la personalità (effetto modeling).
L’altruismo
Altruismo e comportamento prosociale: un problema di intenzioni e motivazioni
Si parla di comportamento altruistico quando vi è un’intenzione di aiutare gli altri e quando il prestare aiuto non è determinato da obblighi professionali, quando cioè è dettato dalla libera scelta. Si preferisce invece parlare di un generico comportamento “prosociale” quando è chiara l’intenzione di portare aiuto, ma non ne è chiara la motivazione. Pertanto, non tutte le azioni prosociali sono anche altruistiche. La decisione per la messa in atto di un comportamento prosociale è frutto di un calcolo di costi e benefici che passa dai seguenti passi: (1) La percezione del bisogno dell’altro; (2) La considerazione della propria responsabilità; (3) la valutazione di costi e benefici; (4) scelta dell’azione da compiere nel portare aiuto.
I fattori situazionali
La decisione di portare aiuto è influenzata anche da una serie di fattori legati alla situazione o al contesto in cui le persone si trovano. Tra questi, il più noto è quello che viene detto “effetto astanti” , per cui a seconda della presenza o meno di altre persone e del contesto, esse vi potranno inibire dal prestare aiuto, o al contrario spingere a fare qualcosa. Nel primo caso Latane e Darly ricondussero questo fenomeno alla diffusione della responsabilità per cui davanti a un incidente, con la presenza di tante persone, si ritiene che già altri abbiano prestato soccorso o che comunque lo stessero per fare. Dalla ricerca di Moriarity si è aggiunto il postulato secondo cui se viene richiesto un aiuto in modo diretto, nella quasi totalità dei casi, gli individui rispondono in maniera positiva. L’effetto bystander è possibile perché la presenza di altri condiziona il modo in cui viene interpretata una situazione ambigua (quando nessuno agisce, si è portati a credere che ci siamo sbagliati, che non c’è un reale pericolo). Lo stesso effetto produce anche l’apprensione dovuta alla possibilità di venire giudicati pubblicamente.
Le norme sociali
Quando però la responsabilità di un’azione non può che essere nostra, e la situazione non è ambigua, la paura a essere disapprovati ci spinge ad agire. Si parla in questo caso di “norma della responsabilità sociale”. È stata anche rintracciata un’altra norma che influenza il comportamento altruistico: la reciprocità spiegherebbe infatti le azioni in aiuto di chi è meno fortunato.
Chi riceve aiuto
Il comportamento prosociale è influenzato anche dal tipo di relazione che lega chi deve dare aiuto a chi ne ha bisogno o lo richiede. Onde per cui si tende a prestare aiuto più alle persone della propria famiglia o agli amici, o a coloro che conosciamo, piuttosto che agli estranei. Sembrerebbe inoltre, che le donne ricevano più aiuto degli uomini ma solo se sono gli uomini a prestare soccorso. In termini generali, saremmo portati a ad aiutare coloro che secondo noi “meritano aiuto”. Nel valutare la richiesta di aiuto, quindi, facciamo inferenze sulle cause del bisogno e siamo portati ad aiutare le persone i cui problemi hanno cause che sono al di fuori del loro controllo personale (se ci chiedono dei soldi per comprare le sigarette, non siamo portati a darli; se ci viene detto che serviranno per mangiare, saremo più propensi ad aiutare).
Colui che aiuta
Le persone differiscono nella loro propensione a portare aiuto, per cui alcuni aiutano in certe situazioni, altri in altre.
Coloro che sentono molto forte il bisogno di essere approvati, sono propensi a fare la carità, ma solo se sono visti da altri. Mentre, coloro che hanno una predisposizione a prendersi cura sono più propensi a risolvere i problemi personali di qualcuno. La spinta ad aiutare deriva anche dalla sensazione che una persona ha di avere la competenza giusta per farlo. Si può inoltre aiutare per compensare un senso di colpa o perché si è di buon umore (e le buone azioni lo mantengono alto) o di cattivo umore (le buone azioni possono farlo risalire). Quindi il comportamento prosociale è il frutto del’interconnessione tra le competenze, i valori, i tratti, gli stati e le motivazioni di una persona e le caratteristiche della situazione.
Altruisti si nasce o si diventa
L’idea che gli individui diventino altruisti essenzialmente a causa delle pressioni esterne è quanto sostengono i teorici dell’apprendimento sociale. Sembrerebbe infatti che anche l’educazione e il modo con cui si impartiscono rinforzi positivi e negativi, induce i bambini a comportarsi più o meno in modo prosociale. Anche l’imitazione offre uno spunto per il comportamento prosociale. In ogni caso, chi compie azioni prosociali avrebbe compiuto un processo di interiorizzazione dello stesso.
Una sorta di egoismo genetico predice quello che viene detto investimento parentale, frutto della selezione parentale.
Questo egoismo dà conto della possibilità che si possa perfino dare la propria vita se questo atto garantisce la sopravvivenza dei propri figli, o in misura minore, dei propri fratelli, cugini, ecc. Quello che non ci si aspetterebbe è quando gli individui si sacrificano per degli estranei, tanto che le società in questi casi, attribuiscono ai protagonisti odi tali imprese, l’appellativo di eroi.
La teoria evoluzionistica prevede che i destinatari del nostro altruismo e delle nostre cure siano, nell’ordine:
1. i figli;
2. i figli più piccoli;
3. i fratelli e poi i cugini, in particolare quelli più giovani;
4. i parenti e poi gli amici;
5. gli amici o coloro che ci assomigliano;
6. i membri del proprio gruppo, piuttosto che quelli di gruppi diversi.
Secondo Wilson, la selezione naturale, utilissima ai primordi, sarebbe oggi la prima nemica della civilizzazione.
.

Cos’è il workaholism
La sindrome da burnout: cos’è, come si manifesta e come affrontarla
STRESS E COPING
Cosa sono il Mobbing e lo Straining
Anorgasmia: Quel disturbo che ostacola l’amore. Come emanciparsene per una vita sessuale più serena e appagante
Il Minnesota Starvation Experiment (M.S.E.)
Cos’è la peer education
IL CYBERBULLISMO
I GRUPPI DI AUTO-AIUTO
Expertimenter: Il film sull’esperimento di Stanley Milgram
L’esperimento di Stanley Milgram: VIDEO
L’esperimento di Stanley Milgram: l’obbedienza alla autorità
L’esperimento di Philip George Zimbardo alla prigione di Stanford
Una introduzione alla teoria sociale cognitiva di Albert Bandura (video)
Albert Bandura, Leading Psychologist of Aggression, Dies at 95 – The New York Times