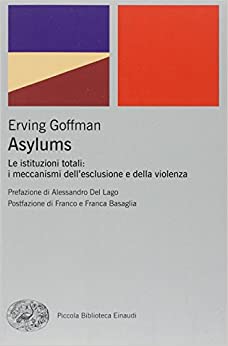Franco Basaglia Scritti I: 1953-1968 – Introduzione ad Asylums
In E. Goffman, Asylums, Einaudi, Torino 1969. In collaborazione con Franca Ongaro Basaglia
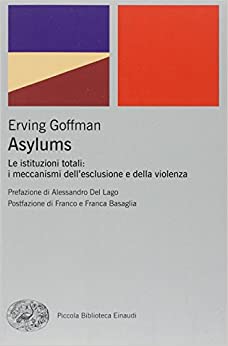
«Si deve scoprire un crimine che si adatti alla punizione e ricostruire la natura dell’internato per adattarla al crimine». Goffman così definisce il significato delle istituzioni totali, smascherando l’ideologia che le sottende e chiarendo la natura esclusoria e discriminante di un intervento, la cui obiettività reale sembra creata dal pregiudizio che l’ha provocato. Ciò che risulta da questa sua affermazione è la necessità della punizione, come partenza originaria attorno alla quale viene a costruirsi e a giustificarsi l’esistenza della istituzione stessa. In un certo senso, questa necessità di punizione corrisponderebbe alla funzionalità delle istituzioni al sistema sociale di cui sono strumento e mezzo di controllo.
L’analisi delle contingenze di carriera che Goffman fa nel ricostruire la storia del predegente, mette in luce l’assenza di un’obiettività concreta nella realtà della malattia mentale e il suo stretto legame con l’elemento soggettivo-interpretativo di chi la definisce e la determina per ciò che è: la scienza (nella sua azione classificatoria e discriminante che fa riferimento al concetto di norma come ad un valore assoluto, nettamente definibile); e la società (che, in base alle indicazioni date dalla scienza, costruisce l’immagine sociale della malattia mentale che sarà determinante nello sviluppo della malattia stessa). Si tratterebbe del risultato di un pregiudizio che, una volta messo in atto, riesce a giustificarsi, facendo combaciare la realtà alla propria ipotesi.
Ora, se si analizza la natura del pregiudizio, è evidente che non si tratta di un atteggiamento psicologico individuale, quanto dell’espressione dei valori della società in cui l’individuo è inserito, risultato di una selezione discriminante fra norma e abnorme, bene e male, maggioranza e minoranza, potere e non potere.
Daniel J. Levinson (in Th. W. Adorno e altri, The Authoritarian Personality, Harper and Bros., New York 1950) illustra, al proposito, un test sul pregiudizio, per sondare l’opinione pubblica su individui, o gruppi di individui, di dubbia localizzazione sociale, come immigrati, negri, criminali, pazzi. L’ambiguità provocatoria di un item come questo («Noi spendiamo troppo per riabilitare i criminali e i pazzi e per l’educazione di persone intrinsecamente incapaci») costringe il testato a prendere apertamente posizione nei confronti di chi non è nella norma, rivelando – in caso la sua reazione sia negativa e discriminante – una personalità «etnocentrica». «Il modo etnocentrico di risolvere i conflitti di gruppo… consiste nel liquidare gli “out”, o tenerli completamente soggetti, segregati in modo da ridurre ogni contatto con gli “in”. Nel primo caso, si tratta di un metodo etnocentrico politicizzato – fascismo e dissoluzione dei valori democratici… L’atteggiamento secondo cui la maggior parte dei gruppi out deve essere soggetta e segregata, è tipico dell’etnocentrismo americano… I valori democratici spesso impediscono il ricorso ad azioni più drastiche, ma possono anche servire a permettere la discriminazione e l’oppressione sotto una facciata pseudodemocratica».
Questo quanto sostiene Levinson circa la situazione americana. Quale sarebbe tuttavia, in Italia, la risposta ad un formulario del genere? Se si può prendere come campione – ridottissimo ma abbastanza significativo – il risultato di una brevissima inchiesta televisiva (spontanea o non, il significato non muta, poiché rivelerebbe le intenzioni di chi l’ha organizzata, se non quelle degli intervistati), parrebbe fossimo ancora drammaticamente pregni dello spirito etnocentrico politicizzato – «fascismo e dissoluzione dei valori democratici» – di cui parla Levinson. Due donne anziane e alcuni giovani, alla domanda del telecronista che introduceva un documentario sull’assistenza psichiatrica in Italia, risposero che, per quanto concerneva loro, il problema dei malati di mente poteva essere risolto solo uccidendoli tutti. La Germania nazista lo aveva già fatto, a tutela della purezza della razza; ma la nostra attuale società non pensa di essere nazista e, purtuttavia, continua ad oscillare fra un estremo e l’altro dell’etnocentrismo, come metodo di soluzione dei propri conflitti e delle proprie contraddizioni.
Il malato mentale – uno degli out della nostra società – è quasi dovunque segregato e soggetto, in istituzioni che non consentono il minimo contatto con gli in e che sono, appunto, deputate ad impedirlo. Le descrizioni minuziose fatte da Goffman dei modi di sopravvivenza degli internati in queste istituzioni, mettono esplicitamente a nudo le responsabilità delle organizzazioni sociali, deputate a gestire le aree delle devianze. L’analisi sulla condizione degli internati non si limita, infatti, all’aspetto apparente del fenomeno, nel considerare gli internati delle diverse istituzioni come il prodotto di una particolarità specifica, tipica di ogni singola categoria; ma tende ad individuare le analogie fra le diverse situazioni totali, dove la diversa specificità originaria (malattia, colpa, abnorme) non risulta la causa prima del livello di regressione e di disumanizzazione che le accomuna.
L’analisi di Goffman parla da sé e non ha bisogno di interpretazioni: con la chiarezza di chi ha individuato ogni risvolto possibile della situazione, ci fa vivere la condizione del diseredato, cui è stato negato il diritto di essere uomo, accomunando in uno stesso destino, colpa, malattia e ogni deviazione dalla norma. Ciò che Goffman riesce a distruggere – attraverso la sua analisi dell’istituzione psichiatrica e le analogie con le altre istituzioni totali – è l’immagine (quindi la cultura) dell’internato mentale, come prodotto di una malattia che distrugge e disumanizza, mostrando lo stesso volto e gli stessi meccanismi di sopravvivenza in istituzioni che con la malattia mentale non hanno niente a che fare. In qualità di non psichiatra (in quanto libero da ogni pregiudizio scientifico al riguardo) Goffman è riuscito a trovare, al di là di ogni classificazione e codificazione, il significato razionale e umano di malati mentali, la cui razionalità e umanità vengono sistematicamente distrutte, all’interno dell’istituzione deputata alla gestione dell’irrazionale e del disumano.
Tralasciando ogni definizione nosografia, egli è riuscito a cogliere le sfaccettature dell’aspetto sociale della malattia (ciò che ne è stato fatto, il significato che le è stato dato, la faccia che ne è stata costruita) individuando il malato mentale come l’oggetto di una violenza originaria, familiare, sociale e istituzionale – «il vortice degli inganni» – confermata dall’etichettamento scientifico che la giustifica. Se si tralascia, infatti, la malattia come fatto reale e se ne considera soltanto l’aspetto sociale, si possono definire i malati di mente come la presenza di un terzo mondo all’interno del mondo occidentale. Che il negro sia negro è indiscutibile, così com’è indiscutibile che esistano le malattie mentali, anche se gli psichiatri in realtà non conoscono nulla sulla loro natura. Ma ciò che ha fatto il negro quello che è stato finora, ha poca relazione con il suo essere nero; cosi come ciò che ha dato al malato mentale la faccia che tuttora ha, ha poco a che fare con la malattia. L’esclusione – come fatto sociale – di cui il negro è oggetto in una società razzista che ha bisogno di sfruttarlo per sopravvivere, è ciò che determina il negro come inferiore e selvaggio; come l’esclusione (come fatto sociale) di cui il malato mentale è oggetto nella nostra società, è ciò che lo determina come inferiore e pericoloso.
Avvicinando il problema da questo punto di vista, è dunque evidente che ciò che viene affrontato e discusso, attraverso la messa fra parentesi della malattia, è il suo aspetto sociale; confortati in ciò anche dalle indicazioni che l’istituzione psichiatrica stessa ci fornisce, dato che essa si occupa della malattia in quanto tale, solo nel momento in cui la definisce e la cataloga, per dedicarsi poi alla gestione dell’esclusione che ne è stata fatta: la custodia. Del resto, è stata la psichiatria che, nel definire il malato come irrecuperabile e incomprensibile ha proposto un’unica possibilità di approccio: quello di natura oggettuale (antiterapeutico per essenza) in una relazione dove il secondo polo del rapporto non esiste, se non come oggetto da inglobare e incorporate nel sistema generale. Sotto la copertura del modello medico, in realtà, l’istituzione psichiatrica tradizionale non è che un’istituzione carceraria, deputata a gestire gli elementi di disturbo sociale.
Lo studio di Goffman ha dunque spalancato le porte delle istituzioni totali, smascherando l’ideologia scientifica – religiosa, custodialistica, pedagogica – che copre la realtà violenta comune a tutte. Ma ciò che Goffman tende anche a mettere a fuoco – seppure in modo ancora incerto e contraddittorio – è la funzione delle istituzioni «deputate a fornire una residenza a categorie diverse di persone socialmente indesiderate. Queste istituzioni comprendono case di cura, ospedali generali, case per anziani, prigioni, cliniche geria- triche, case per mentalmente ritardati, fattorie di lavoro, orfanotrofi e case di ricovero. Ogni ospedale di stato ha una frazione notevole di pazienti che potrebbero benissimo essere ospitati in una di queste istituzioni (così come altre istituzioni ospitano alcuni internati che potrebbero meglio essere ricoverati in un ospedale psichiatrico) ma devono rimanervi perché non è possibile trovare o fornire posto altrove. Ogni volta che l’ospedale psichiatrico funziona come il punto di arrivo in questa rete di istituzioni, per far fronte agli elementi di disturbo sociale, il modello di servizio è rinnegato».
Partendo, dunque, da un’intuizione generale del significato e della funzionalità delle istituzioni nella gestione delle devianze (con l’implicito giudizio politico sul sistema sociale che traccia la linea di divisione fra la norma e la devianza, e deputa queste istituzioni più o meno violente, alla gestione degli indesiderati sociali) Goffman rientra nel problema specifico dell’applicabilità o meno del modello medico in psichiatria. È evidente che – nonostante avverta la dimensione politica in cui ogni problema si muove (non a caso precisa più oltre: «dato che il comportamento inappropriato è di solito il comportamento che a qualcuno non piace e che ritiene estremamente fastidioso, le decisioni in merito tendono ad avere un carattere politico, nel senso che esprimono gli interessi particolari di una data fazione particolare o di una data persona…») – ciò che interessa a Goffman, e che pure è estremamente utile alla distruzione della cultura tradizionale della malattia mentale, è dimostrare la non applicabilità del modello medico in questo contesto, il che presuppone tuttavia una fiducia nel modello medico in generale (il provvedimento psichiatrico è espressione «degli interessi di una data fazione particolare o di una data persona, anziché di un tipo di interessi che possa essere definito come al di sopra di ogni particolarità di gruppo, come nel caso della patologia fisica») e nella neutralità della scienza medica che contrasta con la non neutralità della psichiatria.
Goffman vede nella relazione psichiatra-malato un rapporto di potere come da governatore a governato e ricostruisce, attraverso l’analisi di questo rapporto, la graduale demolizione del sé dell’internato che si trova soggetto a questo potere. Il suo scopo è dimostrare che l’istituzione deputata alla cura del malato mentale è contemporaneamente deputata alla sua totale distruzione, evidenziando così la contraddizione dell’istituzione stessa che, in quanto organizzazione sociale, deve la sua sopravvivenza alla spoliazione di ogni ruolo umano dell’internato in essa incorporato. Qui la violenza è drammaticamente palese, dato che la malattia è essa stessa giustificazione in atto di ogni sopraffazione ed arbitrio: se il malato è incurabile e incomprensibile, l’unica azione possibile è oggettivarlo nella realtà istituzionale, nella cui azione distruttiva egli dovrà identificarsi.
Risulta dunque evidente, dall’analisi di un’istituzione totale quale l’ospedale psichiatrico, che – sotto l’apparenza del modello medico – esso è deputato a gestire l’aspetto sociale della malattia mentale e non la malattia in sé. Nel momento in cui l’istituzione entra in rapporto con il «malato», l’assenza di un’obiettività organica nella malattia, colora di una certa ambiguità la sua azione. In medicina generale si ha a che fare con un corpo malato che esige e giustifica un apparato tecnico che lo ripari. Ma l’istituzione psichiatrica, di fronte ad un individuo che deve ricoverare perché non è più tollerato nella società esterna – perché ha varcato il limite della norma da essa fissato – pare solo presumere un corpo malato e, in base a questa presunzione, si limita ad oggettivarlo come se fosse malato, instaurando un rapporto che non ha nulla di terapeutico, dato che perpetua l’oggettivazione del paziente, fonte essa stessa di regressione e di malattia. Così, come Goffman sostiene che « si deve scoprire un crimine che si adatti alla punizione e ricostruire la natura dell’internato per adattarla al crimine», si può dire che l’istituzione psichiatrica, una volta oggettivato ü paziente come se si trattasse di un corpo malato, deve ricostruire quel corpo, per adattarlo all’oggettivazione che ne ha fatto.
Presumere un corpo malato, come base di incontro fra psichiatra e paziente mentale, significa imporre a quest’ultimo un ruolo oggettivo sul quale l’intera istituzione che lo tutela viene a fondarsi. Il particolare tipo di approccio oggettivante finisce, quindi, per influire sul concetto di sé del malato, il quale – attraverso un tale processo – non può non viversi che come corpo malato, esattamente nel modo in cui è vissuto dallo psichiatra e dall’istituzione.
L’istituzione, nata per curare una malattia di cui risultavano ignote l’eziologia e la patogenesi, si è trovata cosi a fabbricare un malato a sua immagine, tale da giustificare e garantire insieme, i metodi su cui fonda la sua azione terapeutica. La malattia è venuta a trasformarsi gradualmente in ciò che è l’istituzione psichiatrica, e l’istituzione psichiatrica trova nell’internato, costruito secondo i suoi parametri, la conferma alla validità dei suoi principi. Proponendosi come un’istituzione medica e non trovando un’obiettività concreta nella malattia, l’istituzione psichiatrica è costretta ad oscillare fra l’azione custo- dialistica (che è la sua unica realtà) e l’ideologia medica che è costretta a concretare nel rapporto oggettivo con il paziente.
Ma, al di là della contraddizione palese che Goffman denuncia fra le finalità ideologico-scientifiche e la quotidianità concreta dell’istituzione psichiatrica, si può intrawedere un’identità fra la realtà istituzionale (oppressiva, mortificante e distruttiva) e la funzionalità dell’istituzione in rapporto al nostro sistema sociale che sopravvive appunto escludendo (quindi opprimendo, mortificando e distruggendo) gli elementi di disturbo. Da questo punto di vista l’analisi di Goffman – necessaria allo smascheramento della natura carceraria, custodialistica e, entro certi limiti, sadica dell’organizzazione psichiatrica che, sotto la copertura del modello medico, agisce come una pura istituzione violenta – si ferma, limitandosi a rendere esplicita la contraddizione fra ideologia e realtà.
Ma sarebbe sufficiente applicare realmente all’istituzione psichiatrica il modello medico, renderla cioè tecnicamente efficiente, per risolvere le sue contraddizioni? Se l’istituzione psichiatrica è deputata alla gestione dell’esclusione (la faccia sociale della malattia mentale) in che modo possiamo garantire che, applicando il modello medico ad una nuova istituzione psichiatrica, che superi attraverso tecniche psicologiche l’oggettivazione del malato, avremo risolto il problema sociale della malattia mentale? Il rapporto di potere all’interno dell’istituzione non continuerebbe a sussistere fra il tecnico che presta il suo servizio continuando a stabilire i valori di norma, e il malato che, in base ad essi, viene discriminato? In che modo la psichiatria diventerebbe neutrale (cosi come Goffman sembra ritenere neutrale la medicina generale) nel momento in cui è sempre facoltà dello psichiatra – come espressione della società di cui è delegato – stabilire i limiti della norma e il grado di permissività cui la società che egli rappresenta è disposta? Da dove nasce la fiducia di Goffman nella neutralità tecnica della medicina generale, se la relazione fra medico e malato risulta compromessa dalla natura socio-economica che sottende ogni rapporto? Entro certi limiti, la curabilità o l’ineluttabilità della propria malattia sono proporzionali alla nostra possibilità di gestirla in proprio, cioè al potere contrattuale che il malato ha nei confronti del medico.
La medicina, come ogni altra scienza nella nostra cultura, è una scienza di classe, di cui la psichiatria è forse l’espressione più palese e più drammatica, dato l’enorme divario fra l’assistenza nelle case di cura private e la gestione degli internati nei manicomi provinciali. Ma questo divario non è assente nelle altre branche della medicina: il malato di corsia e il dozzinante vivono il rapporto psicologico – se non anche quello tecnico – con il medico, ad un livello completamente diverso, essendo il primo in balia dell’arbitrio del personale curante, in quanto privo di un ruolo sociale capace di controbilanciare quello del medico. Il potere contrattuale è ciò che determina la natura del rapporto, che si rivela cosi ancora economico e di classe.
Forse per lo psichiatra istituzionale – più che per il cosiddetto scienziato puro — il rapporto fra scienza astratta e internato è più strettamente evidente: la realtà manicomiale, come risultato di una scienza che ha avuto la funzione di discriminare l’abnorme e di definirlo nei suoi diversi aspetti, è di un’efferatezza cosi palese che, non appena lo psichiatra si renda conto di quale sarebbe la sua funzione all’interno di quell’istituzione, non può non sentirsene complice e rifiutare il suo ruolo. Lo psichiatra si trova a godere del pesante privilegio di avere direttamente sotto agli occhi il risultato di una violenza che è sua, della società e dell’istituzione. Se solo incominci a sospettare che la realtà malata che gli sta di fronte – internati che non parlano perché nessuno li ascolta; che non camminano perché non sanno dove andare; che sbavano perché non c’è una ragione per non farlo, uno scopo, un fine per cui abbia un senso resistere alla tentazione di lasciarsi vivere e vegetare – non sia solo il frutto di una malattia, ma il risultato di una violenza perpetrata a tutti i livelli, questa realtà non può non capovolgersi ai suoi occhi, coinvolgendolo nella sua parte di responsabilità e coinvolgendo i «sani» nella loro.
Se ogni giorno – al di là dei suoi calcoli astratti – il fisico nucleare dovesse fare i conti con le vittime di Hiroshima e Nagasaki, riuscirebbe a sostenere la neutralità della scienza cui si dedica, come se l’uso fatto dei risultati da lui ottenuti non si trovasse a sovrapporsi e a coincidere con la finalità della sua stessa ricerca scientifica? È diffìcile dimostrare la neutralità della medicina, come prestazione di un servizio tecnico, che trascenda ogni tipo di rapporto di natura più specificamente socio-economica, se non addirittura politica. ( Ne è un esempio (da ritenersi l’aspressione più pura di un’intenzione che non ha più paura di smascherarsi) la posizione presa in questi giorni da un’amministrazione provinciale, di fronte allo stralcio di legge n. 431 in data 18 marzo ’68 sull’assistenza psichiatrica, che tende alla liberalizzazione degli ospedali psichiatrici attraverso l’introduzione del ricovero volontario: esso sfugge al controllo giuridico, tipico del ricovero coatto, e consente così la graduale riduzione dei pazienti soggetti al marchio sociale. Di fronte a questi primi tentativi legali di ridurre la natura della distanza che separa il paziente che può permettersi una cura in cliniche private (sfuggendo quindi allo stigma della malattia mentale) e colui che ha come unica possibilità il manicomio, l’amministrazione provinciale di cui sopra invita e impone ai medici dell’ospedale psichiatrico che da essa dipende, di consentire il ricovero volontario solo ai pazienti dozzinanti e, in caso non siano assistiti dagli enti mutualistici, previo deposito cauzionale di lire ioo 000, ridotto in una circolare successiva a lire 50 000.
È evidente come, anche all’interno di una legge riformistica che tende a modificare le contraddizioni più sfacciatamente palesi della nostra assistenza psichiatrica, si continui a perpetuare – sfruttando l’ambiguità interpretativa della legge – la abituale discriminazione fra chi ha e chi non ha, subordinando la definizione di pericolosità, tipica del ricovero coatto, alle condizioni economiche del paziente. In questo modo viene svuotato dall’interno il significato della legge stessa.)
L’analisi di Goffman sui tecnici come prestatori di un servizio serve dunque a chiarire la natura oggettuale del rapporto fra psichiatra e malato mentale (le analogie implicite fra l’oggetto da riparare che il cliente consegna al tecnico, aggiungono drammaticità alla condizione dell’internato diventato, in questo contesto, un oggetto che non può essere riparato e che tuttavia continua a funzionare), ma trascura esplicitamente una dimensione senza la quale il discorso resterebbe monco o limitato («la categoria di chi presta un servizio, cosi com’è stata qui definita, non ha alcun riferimento a suddivisioni di classe o di censo»).
Per questo – oltre l’acuta analisi sociologica e fenomenologica della condizione dell’internato di cui Goffman sviscera e approfondisce ogni aspetto ed ogni risvolto (con le implicazioni per la struttura del sé presenti in ogni regola istituzionale) – si sente la necessità di affrontare la condizione dell’internato, non solo come un dato di cui è necessario conoscere ogni modalità di esistenza, ma come un prodotto che ci consenta di risalire dalla condizione di esclusione tipica dell’internamento, all’individuazione di ciò che lo produce e della natura del rapporto che unisce ciò che esclude all’escluso, e che spieghi la funzionalità e il significato dell’istituzione deputata alla gestione dell’esclusione. In questo senso il problema si apre sulla funzionalità sociale delle istituzioni totali, deputate a gestire le nostre contraddizioni più palesi.
Ciò che risulta subito evidente – oltre la violenza di questa gestione – è un fatto costantemente ricorrente: nella società capitalitico-produttivistica la norma è la salute, la giovinezza, la produzione. La malattia, la vecchiaia, l’infortunio sono accidenti all’interno di una realtà che non vuole e non può premunirsi e preoccuparsi delle proprie contraddizioni.
In ogni società si vive, ci si ammala, si diventa vecchi, si è soli. Ma una società produttivistica che si fonda sull’ideologia del benessere e dell’abbondanza per coprire la fame, non può programmare sufficienti misure preventive o assistenziali. Si salva ciò che può essere facilmente recuperato; il resto viene negato attraverso l’ideologia dell’incurabilità, dell’incomprensibilità, della natura umana, su cui si costruisce il castello del pregiudizio. Nella società dell’abbondanza-fame o c’è abbondanza o c’è fame. Ma la fame (con tutti i significati che questa parola comporta) non può manifestarsi brutalmente per ciò che è (ciò che consente all’abbondanza di essere e di mantenersi tale), ma deve venir velata e schermata attraverso le ideologie che la definiranno di volta in volta come vizio, malattia, razza, colpa.
Importante è che le contraddizioni – inevitabili in ogni tipo di società – vengano sancite come un dato irriducibile, come condizione insanabile insita nell’uomo e nella sua natura, oltre la quale l’uomo non può nulla. È in questo senso che il manicheismo del sì e del no, del bene e del male, della salute e della malattia, dell’abbondanza e della fame, è costretto a fondarsi sull’ideologia del bene, della salute, dell’abbondanza come unica realtà e possibilità umana: il resto è il risultato di un fallimento che troverà spiegazioni scientifiche e filosofiche, in una scienza e in una filosofia che maschereranno il loro legame con la classe dominante, sotto la mistificazione della neutralità tecnica. Solo in questo senso si può comprendere l’assurda incuria e l’assoluta mancanza di previdenza (sempre insufficiente rispetto alle necessità) del nostro sistema sociale, paragonabile alla cicala che continua a cantare l’estate e l’abbondanza, per nascondere la fame dell’inverno.
Nel nostro sistema sociale non c’è posto per la dialettica: o si è formiche, alienate nella produzione; o cicale imprevidenti destinate a morire. Finché la divisione fra bene e male è netta, i pochi che detengono il potere dispongono di un’arma sicura per creare una distanza, umanamente accettabile, fra chi ha e chi non ha. I valori sono fissati una volta per tutte dalla classe dominante e da una scienza che la difende, ma solo chi non ha, cade nelle sanzioni studiate per dominarlo e indebolirlo. Se le malattie sono incurabili, la prostituzione è vizio, la fame ineliminabile, la violenza è colpa; la malattia, la prostituzione, la fame, la violenza sono il polo negativo di un dato irriducibile, e non ciò che consente alla salute, alla purezza, all’abbondanza, alla pace di essere ciò che sono.
L’ospedale psichiatrico, come tutti i luoghi di internamento, non è che la triste conseguenza della copertura di una contraddizione, attraverso l’ideologia dell’ineluttabilità e dell’incomprensibilità della malattia. Se la malattia può essere considerata una contraddizione, non si può risolverla negandola in quanto tale e soffocandola sotto una qualsiasi ideologia. Il significato di una comunità psichiatrica dovrebbe consistere nel rendere più esplicite le contraddizioni inerenti il background sociale su cui la malattia mentale si sviluppa, in modo che il paziente riesca ad individuarle, dialettizzarle, e affrontarle. Ma com’è possibile se egli è stato negato in quanto contraddizione in atto rispetto alla norma, attraverso l’ideologia psichiatrica che lo ha definito e fissato entro limiti invalicabili?
L’analisi di un’istituzione totale, funzionale ad un sistema sociale come il nostro, è dunque la dimostrazione di quanto paga chi si trova costretto a pagare, per dare agli altri la possibilità di vivere nella «norma» e nel «benessere».
Il disturbato mentale inizia abitualmente la sua carriera «con un’infrazione alle norme del vivere sociale, nel proprio ambiente familiare, nel posto di lavoro, in un’organizzazione semipubblica come una chiesa o un grande magazzino, in zone pubbliche come strade o parchi. Spesso la cosa viene riferita da un accusatore che risulta così colui che ha dato l’avvio al ciclo che porterà l’accusato all’ospedalizzazione. Costui può anche non essere quello che fa il primo passo, ma quello che ha portato alla prima azione determinante. È qui che comincia socialmente la carriera del paziente e ciò prescindendo dal momento in cui può collocarsi l’inizio psicologico della sua malattia mentale».
La netta separazione fra salute e malattia non esiste: il malato mentale è in balia delle circostanze che faranno precipitare la situazione o la lasceranno inalterata. L’obiettività non c’è fino al momento in cui non viene costruita dall’atto stesso dell’internamento e dalla definizione di malattia. Prima di allora, tutto è ancora possibile, perché quello che sarà il futuro malato mentale è ancora considerato una presenza contraddittoria nella realtà in cui vive: il datore di lavoro che si lamenta delle sue stranezze, il familiare che lo colpevolizza per il suo comportamento, stanno ancora pretendendo da lui qualcosa, il cui ottenimento lo manterrebbe ai loro occhi su un terreno d’uguaglianza. Lamentarsi di un comportamento presume ritenere la possibilità che un tale comportamento venga modificato in seguito al proprio intervento, tenendo conto, contemporaneamente, delle ragioni che verranno opposte a spiegazione o a giustificazione del comportamento stesso.
Ma è il tecnico (il mediatore prima e il professionista specialistico poi) che sembra strappare il malato da questo rapporto ancora personale (con la possibilità di una reciproca aggressività e di una reciproca difesa in esso implicita) per fissarlo in un ruolo oggettuale, nel momento in cui diventa l’oggetto della loro ricerca e della loro cura. Nei suoi rapporti con i mediatori, difficilmente il malato viene contraddetto o rimproverato: la realtà comincia, già molto prima del suo internamento definitivo, ad apparirgli ambigua e gradualmente sempre più aproblematica, nel senso che, se originariamente egli voleva – attraverso acting- out qualche volta apparentemente ingiustificati – contestare il mondo, ora è il mondo stesso a venirgli incontro lasciandosi contestare in modo irreale. Questa azione del mediatore e del tecnico assume così il significato di un giudizio che definisce e nello stesso tempo de-responsabilizza il comportamento del malato, aiutandolo a staccarsi dal reale, il cui confronto è per lui tanto problematico. Quando questo giudizio tecnico sia stato formulato, il malato cessa di essere vissuto da chi lo circonda, come un problema costante che richiede costanti prese di posizione reali, per diventare un fantasma, liberato di volta in volta da ogni vincolo di responsabilità e di consapevolezza. Il che agisce su di lui come la dimostrazione che il fatto di essere stato riconosciuto malato dai tecnici, lo autorizza a regredire perdendo ogni controllo sulla propria vita.
Fintantoché la malattia mentale era considerata una delle modalità umane con cui l’uomo conviveva, esisteva fra società e malati un rapporto del tipo malato-accusatore: una partecipazione all’abnorme attraverso una vita comune, in cui il malato conserva, agli occhi della società, il suo carattere contraddittorio, così come lo conserva la realtà agli occhi del malato. Ma con lo svilupparsi della società industriale la linea di separazione fra norma e abnorme ha incominciato ad assumere un significato particolare, che si accentra sul concetto di produttività: la distanza fra salute e malattia è stata esasperata, facendo precipitare coloro che stavano in bilico fra l’una e l’altra.
Dal momento della liberazione dei folli di Pinel, dalle carceri della Bicêtre, dov’erano confusi con la colpa e il peccato, si è assistito ad una sorta di dilatazione scientista in cui l’area delle devianze e delle malattie mentali si è andata a mano a mano enfatizzando, assorbendo il terreno stesso, da un lato, della delinquenza, e dall’altro del disadattamento. La nostra società attuale preferisce definirsi «malata» anziché riconoscere nelle proprie contraddizioni il prodotto del sistema su cui si fonda. In un certo senso, la malattia deresponsabilizza sia la società che il singolo; il terreno delle competenze risulta confuso, soprattutto se la malattia conserva in sé una parte oscura di colpa, e la colpa una traccia di malattia.
Ma ora è stata smascherata la funzione dei malati mentali come uno dei «capri espiatori» di un sistema che ha bisogno di aree di compenso per sopravvivere, e si tenta di correre ai ripari attraverso la liberalizzazione degli ospedali psichiatrici. La faccia sociale della malattia mentale potrà forse incominciare a mutare attraverso la nuova cultura che verrà creandosi e, forse, sarà possibile incominciare ad occuparci della malattia in quanto tale. Ma, in questo caso, quale sarà la nuova area di compenso, qualora il malato mentale venga riabilitato e reintegrato nella nostra attuale società? Un sistema fondato sull’ideologia dell’opulenza non può risolvere né smascherare le sue contraddizioni, che le ideologie sono appunto deputate a nascondere. Quali saranno dunque i nuovi out da escludere e da coprire?
Basterebbe assorbire – e ce ne sono già le indicazioni – nella sfera delle devianze ogni disadattamento, ogni segno di rifiuto nei confronti del tipo di società in cui si è costretti a vivere, e farli cadere sotto la giurisdizione psichiatrica, per costruire scientificamente un nuovo alibi, che converta in patologia ciò che è aperto segno di dissenso verso una vita invivibile, che può ancora essere diversa. In questo caso, quale sarà la posizione degli psichiatri, dei tecnici? Sanciranno, ancora una volta, nella loro qualità di delegati del potere, un’esclusione sociale sotto l’etichetta della malattia?
O lo smascheramento di ciò che è stata la loro azione istituzionale li rivelerà – ai loro stessi occhi – come semplici strumenti di controllo sociale, in balia del sistema che li determina? È possibile, in queste condizioni, parlare di scienza, se non si chiarisce prima che cos’è la politica di questa scienza?
Tutto ciò può essere facilmente tacciato di ovvietà. Non è una novità individuare e rifiutare la sopraffazione dell’uomo sull’uomo; non è una novità cercarne le cause, rifiutando di coprirle sotto il pregiudizio. Ma finché la sopraffazione e la violenza sono ancora l’ovvio leitmotiv della nostra realtà, non si può che usare parole ovvie, per non mascherare sotto la costruzione di teorie apparentemente nuove il desiderio di lasciar le cose come sono.